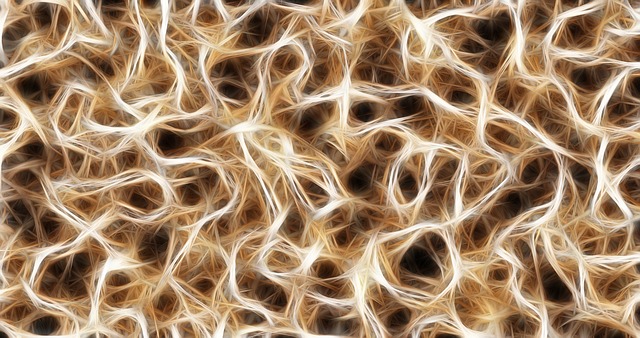
geralt (CC0), Pixabay
di Roberta Sallustio
Il rapporto mente-corpo, anche in psicoterapia, nasconde dei tranelli in cui è facile cadere, alla ricerca di una spiegazione del sintomo fisico come manifestazione o conseguenza di qualche elemento che sia causa o effetto, presente o passato, nella vita delle persone. L’articolo vuole mostrare il rapporto sempre stretto che c’è tra l’andirivieni tra la salute fisica e la vita delle persone e su come la vita di una persona e i suoi sintomi fisici diventino vicendevolmente contesto gli uni degli altri, come creino significati, come la vita possa dare significato a un sintomo e come un sintomo dia significato a quello che succede alle persone.
Ritengo che ogni richiesta di aiuto abbia di per sé un desiderio di cambiamento verso un miglioramento della qualità della vita, una delle mie prime premesse, che penso abbiano consentito di accogliere quello che ho sentito essere una domanda lecita ma che portava in sé un obiettivo difficile da raggiungere, o meglio impossibile: la richiesta di intervenire sulla mente per correggere ciò che nel corpo funziona male. Una domanda che ha messo in gioco la necessità di esplicitare e rendere più chiare in me, oltre che nella persona che incontro in seduta, le differenze tra cura, terapia, guarigione, salute e malattia e comprendere quali fossero le idee e i pensieri relativi al rapporto mente-corpo.
Da dove arriva quest’idea così semplice che mente e corpo sono causalmente connessi? In che modo ho provato a praticare sistemicamente anche incontrando aspettative imbevute di finalità cosciente? Le attese, le domande e le storie del sig. Claudio e del sig. Remo mi hanno permesso di interrogarmi e riflettere se, e in quale modo, io sia riuscita a rinunciare a “ogni fantasia di cura, guarigione, crescita, miglioramento del sé, consapevolezza […] alle interpretazioni, alla salute mentale pensata a priori” (Telfener, 2012) e in questi specifici casi alla salute pensata a priori e alla differenza tra cura e prendersi cura.
Le riflessioni delle relazioni tra persona e ambiente sono presenti dagli albori dell’umanità, nella filosofia antica il rapporto mente-corpo pone le basi della posizione dualistica, ma è con Cartesio che il pensiero occidentale fonda un principio di separazione tra mente e corpo. Anche se Cartesio descrive che la distinzione tra res cogitans e res extensa vada intesa come una mutua interdipendenza tra mente e corpo, “la natura mi insegna pure che io non sono meramente presente al mio corpo come un nocchiero lo è al suo vascello, bensì gli sono congiunto quanto mai strettamente e (per così dire) mescolato, in modo da comporre un’unità con esso” (Gritti, 2019), sembra divenire fondante delle concezioni sull’organismo umano il suo pensiero di separazione tra spirito e materia, tra reale, ciò che è misurabile, e irreale. “Descartes era determinato a non considerare vero alcunché, prima di aver stabilito le prove per accertarlo come tale” (Lock & Scheper-Hughers, 2006) con l’unica certezza dell’essenza pensante. La mente razionale viene separata dalla natura, diviene l’elemento che permette un rigoroso esame oggettivo della natura stessa presupposto delle scienze naturali e sociali occidentali per secoli.
La ricerca del “reale” e della “verità” diventano confini entro cui si sviluppa l’epistemologia occidentale, strutturando un susseguirsi di separazioni dicotomiche su corpo, mente, natura, cultura, società basandosi sul principio della causalità lineare, “in un nucleo di verità fondanti su cui basare scelte e decisioni” (Ceruti, 2018). Forse anche a partire da ciò che ritroviamo un’abitudine a pensare che se un evento non sta andando nella direzione desiderata, se sopraggiunge un problema o una difficoltà, quando le cose della vita non funzionano come “dovrebbero”, allora si ricerca una causa o le cause per comprendere e agire di conseguenza alla ricerca delle soluzioni idonee. Una lunga catena di cause ed effetti, ordinatamente collegati, diviene un riferimento secondo cui “ogni problema, per quanto ampio, poteva quindi venir frammentato in problemi minori che venivano a loro volta venir analizzati e risolti razionalmente, uno alla volta” (Bert, Quadrino, 2002). Questo principio nel tempo diviene anche motore del progresso scientifico che parcellizza, osserva, annota, spiega e descrive particolari che, con il supporto tecnologico divengono sempre più infinitesimali. Sostiene ancora Ceruti che nella scienza emerse “l’ideale di oggettività razionale, espressione di un osservatore esterno e disincarnato”, con il paradosso che, con il progredire della conoscenza tecnico scientifica, ci si allontana maggiormente da una visione complessiva e interconnessa dei sistemi viventi nei contesti.
Il “divenire umano” rischia, dunque di essere parcellizzato da un’ottica che osserva l’interazione lineare tra causa ed effetto, input e output, cosicché la persona, e in particolare il suo corpo, è pensata e percepita come “macchina banale” (von Foerster, 1987), determinabile analiticamente, indipendente dalla storia e prevedibile, nella prospettiva che ogni inconveniente possa essere identificato e possibilmente corretto.
Nelle discipline mediche è ancora presente l’abitudine a considerare il corpo come una macchina e la patologia come un guasto da riparare. Le malattie risiedono all’interno dell’individuo, in un individuo che, a volte per un motivo inspiegabile, funziona male e perlopiù è osservato come entità a sé stante, omettendo di tenere conto del suo continuo contatto col mondo. Il corpo parcellizzato e oggettivato della scienza dimentica che “il complesso non è una combinazione di elementi semplici, che l’organismo non è un mosaico di fatti fisico-chimici ma è una totalità” (Galimberti, 1983).
La medesima domanda, prima di Remo e qualche mese dopo di Claudio: “mi aggiusti la mente perché io ho il corpo che non mi funziona come vorrei”, ha acceso in me la scintilla di cosa vuole dire tenere presente la relazione causale e il pensiero lineare che arriva nella stanza di terapia. Il processo causale “è ben radicato nel pensiero popolare” (Asen et al., 2004) e questo ci fa correre il rischio, come psicoterapeuti, che ci venga attribuita la capacità tecnico-specialistica di riparare “l’ingranaggio mente”, vicini al popolare stereotipo professionale dello “strizzacervelli”, che spreme via ciò che è dannoso.
Entrambe le persone arrivano, presso lo studio professionale privato, inviate dal medesimo medico di medicina generale che, nel principio perfetto di delega tra uno specialista e l’altro, individua me come l’esperta che potrà aggiustare il loro “ingranaggio mente” per assolvere alla loro richiesta di avere il proprio corpo che funzioni meglio.
Claudio è una persona di 40 anni che da vent’anni ha ricevuto una diagnosi di colite ulcerosa. Insegnante di arrampicata indoor e outdoor, si presenta dicendomi: “mi sono preso un anno sabbatico, perché ho bisogno di lavorare su di me, di prendermi del tempo perché questa malattia voglio risolverla, perché non sto facendo le cose giuste nella vita”. La colite ulcerosa è una malattia cronica dell’intestino, con eziologia sconosciuta su base autoimmune, recidivante in cui si alternano fasi di acuzie con fasi di remissione dei sintomi caratterizzati da forti dolori addominali e diarrea. Claudio ha l’aspettativa che prendersi cura di sé, attraverso un percorso psicoterapeutico, determinerà l’eliminazione della sintomatologia.
Remo, invece, è inviato con la supposizione da parte del medico di base che sia presente una fobia o una malattia psicosomatica, dato che non si rilevano cause organiche al suo malessere. Entra timidamente, con una stretta di mano all’ingresso dello studio veloce e leggera; capisco poco dopo che quel convenevole è già una prima difficoltà da affrontare. Mi spiega che “ci sono due cose mi rovinano la vita”. La prima è una sudorazione diffusa nel corpo, in particolare alle mani, e la seconda è la sua percezione di emanare odore, di avere una sorta di aerofagia, impalpabile, incontenibile, che gli impedisce di stare con le persone che, piano piano, determina un ritiro sociale. Remo, quarantaseienne, single, lavora come portiere di notte per un albergo e vive nella casa genitoriale, afferma di sentirsi pronto a mettere a posto il suo corpo che funziona male.
Il tema del medico inviante, comune per entrambi, mi ha permesso di riconoscere immediatamente il potere che l’inviante stesso ha nel definire il contesto del lavoro. Ho sentito l’importanza di tenere presente le premesse e la convinzione che attraverso di lui sono arrivate al primo momento del colloquio nelle parole di Claudio e Remo. Nell’esasperazione di una ricerca impossibile di soluzioni alle esigenze di entrambi nel vedere interrompersi la sintomatologia fisica, il medico trova una soluzione nello “spedire” la persona in terapia (Selvini Palazzoli et al, 1988).
Aderire all’indicazione del medico, per i pazienti, è riconoscere che egli sia in grado e sia competente a individuare la soluzione adeguata, ma immediatamente correndo il rischio di associarsi al modello lineare causale che il pensiero bio-medico ha in sé, anche in una successione di deleghe tra professionisti sanitari. Nella stanza, oltre alle mie premesse e a quelle della persona seduta davanti a me, erano ben presenti anche le premesse di cos’è salute e malattia, cos’è cura, cos’è terapia del medico inviante per un paziente come Claudio con una malattia cronica, quindi inguaribile e per Remo, dato il sospetto che sia una sintomatologia fondamentalmente inventata, dunque inesistente, e necessariamente un problema di ordine di salute mentale.
Sulle saluti e sulle malattie
Il termine salute viene unicamente usato nella sua forma singolare, non rientra nel nostro linguaggio la possibilità di raccontare, discorrere e riflettere sulle saluti, il che sembra essere una conferma, inoltre, che l’uso del linguaggio rispecchia ed è determinato dal pensiero e le premesse a cui è legato. La salute è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità “come stato completo di benessere fisico, mentale e sociale”. Se da un lato viene superata la concezione di salute come assenza di malattia, contemporaneamente questa definizione esprime un’idea statica di salute come condizione da raggiungere e/o, utopisticamente, mantenere. La salute rischia di diventare assenza di segni e sintomi, assenza di malattia, riduzione dei sintomi positivi, riduzione di turgore e calore o, nella migliore delle ipotesi, con una buona riabilitazione o l’utilizzo di una buona protesi, il recupero delle funzioni perdute.
Secondo Foucault (1963) la medicina comprende la conoscenza dell’uomo in salute, cioè l’esperienza della persona senza malattia, così da darne sia una definizione sia un modello; il che nella definizione delle condizioni di salute, delle condizioni di normalità, ne delinea una norma. Nella pretesa dell’oggettività, la malattia stessa è osservabile attraverso uno sguardo normato e contemporaneamente normante perché decide e definisce i confini della normalità. La salute mentale, nella sua componente “salute”, è concepita nel pensiero comune con le stesse caratteristiche della salute fisica? Quanto è possibile nella relazione con il paziente che arriva in seduta, considerare e ristrutturare l’idea di salute come assenza di sintomi e non come conditio sine qua non del benessere? Inoltre, se “normare, normalizzare significa imporre un’esigenza a un’esistenza” (Canguilhem, 1996) nella cornice deterministica della relazione mente-corpo, il principio di causalità di una difficoltà fisica o esistenziale diviene prerequisito implicito delle relazioni di cura. C’è una norma, di esclusiva proprietà del professionista esperto, che delinea quale sia la finalità del “trattamento” in direzione di quella salute definita precedentemente.
La cura rischia, dunque, di diventare esclusivamente sinonimo di terapia, quest’ultima intesa come agente esterno farmacologico, tecnico o strumentale atto a “guarire” o ripristinare. Questo sembra favorire un principio di delega fondato sul fatto che chi chiede una cura, è piuttosto certo dell’esistenza, in chi pratica la cura, di una conoscenza capace di trovare una spiegazione e produrre, con tecniche e strumenti, il cambiamento desiderato finalizzato a raggiungere il benessere.
La ricerca di senso, cioè la comprensione del proprio “stato di salute”, si pone su un piano differente e distante dalla ricerca delle cause. Questo potrebbe spiegare il proliferare e il successo di forme alternative di cura, in particolare modo quelle che si rifanno a tradizioni non occidentali di terapia, alla ricerca di una visione meno accanitamente deterministica. Damasio (1994) sostiene, e sembra essere ancora attuale la sua considerazione, che “il favore di cui attualmente godono le medicine alternative è una spia della diffusa insoddisfazione per l’incapacità, da parte della medicina tradizionale di considerare l’individuo umano nella sua interezza” ed è cogliendo l’interezza e l’interdipendenza, e non dalla separazione tra le parti, che si può approfondire la dimensione della salute-benessere.
Tornando alla definizione dell’OMS, in quali momenti possiamo davvero descriverci in salute con la presenza di un benessere, fisico, mentale e sociale? È possibile nel senso comune, nel discorso pubblico, nelle premesse implicite, nella cultura in cui siamo immersi, per ciascuno di noi e per le persone che si rivolgono a un professionista sanitario, considerarsi in salute anche in presenza di malattia?
Il termine sanscrito salvas ha un significato equivalente a quello che noi in italiano chiamiamo sano, intero e anche “è la radice, è l’origine di due parole che in italiano descrivono due mondi fondamentali e determinanti della cultura occidentale moderna […] Salute e Salvezza” (Di Lernia, 2008). Questi termini rimandano a un’origine in cui l’intero, il sano è unito, completo, totale, comprensivo del tutto, di mente e corpo, di spirito e materia, della natura. È con la modernità che le due dimensioni si separano in due distanti visioni del mondo: la scienza e la fede.
Scienza e fede, medici e preti sono anche designati a rispondere alla domanda “perché”? In che modo sanarci e salvarci dalla sofferenza?
Ma se la domanda porta una ricerca di senso e la risposta spiega una causa si corre il rischio di sovrapporre malattia e colpa. La spiegazione causale può divenire un approccio colpevolizzante che porta in sé una connotazione morale dell’idea di cura, “un nesso stringente, necessario, tra salute e comportamento morale” (Di Lernia, ivi).
Il tema della moralizzazione della malattia viene espresso anche attraverso il linguaggio. Le metafore sono connaturate in noi e incarnate e, in quanto rappresentazioni personali, relazionali e sociali, Sontag (1977) ci mette in guardia dal potere ingannatore delle metafore applicate alla malattia, affermando che “non c’è niente di più primitivo che attribuire a una malattia un significato, poiché tale significato è inevitabilmente moralistico”. Ciò può portare le persone a ritenere che se la malattia è un giusto esito di un comportamento sbagliato, la responsabilità individuale diviene quella di introdurre nuovi comportamenti, il cui esito sarà la remissione della malattia. La malattia diviene il fenomeno espresso nel corpo della propria colpa, la salute l’espressione di un agire valoroso. Le malattie in qualche modo sono viste come forme di incapacità, di insufficiente volontà e come sostiene ancora Sontag “di autocondanna, di autotradimento [dove] la mente tradisce il corpo”, dove la cura verso la guarigione diviene una sfida, una necessaria messa in campo di tutte le armi a disposizione.
La metafora bellica con cui maggiormente viene narrata la salute e la “battaglia” alla malattia, raffigura, e contemporaneamente definisce, i confini della rappresentazione possibile dei percorsi di cura. Come in guerra, si potrà sparare bene i propri colpi, per sconfiggere il nemico, sperando di salvarsi la pelle e magari diventare un eroe. D’altronde è agli eroi che viene assegnata la medaglia al valore; ma se sono affetto da una malattia, posso considerarmi ugualmente una persona di valore?
Il lavoro di Sontag è divenuto “un riferimento obbligato” (Lingiardi, 2018) alla riflessione sulla salute, non tanto perché sia davvero attuabile una de-metaforizzazione delle rappresentazioni del mondo ma per far emergere e tener conto delle premesse, degli impliciti, dei limiti e, di conseguenza, delle possibilità con cui le persone potrebbero arrivare in seduta.
Ci sono due immagini che rappresentano l’incontro in prima seduta con Claudio e con Remo che sono state gli elementi osservati durante l’analisi della domanda che ritengo essere un atto iniziale rispettoso del consenso e già di per sé promotore di un’assunzione di responsabilità da parte della persona presente in seduta, che veicola fortemente un principio di equità tra terapeuta e cliente.
L’immagine presente al termine del primo colloquio è stata quella che Claudio si sentisse simile a Kafka quando, scrivendo della diagnosi appena ricevuta dice: “segretamente non credo che questa malattia sia tubercolosi, o almeno non principalmente tubercolosi, ma un segno del mio fallimento generale”. La decisione di prendersi cura di sé per “sconfiggere” quella malattia altro non sembra che l’epifenomeno del suo disvalore.
Remo, invece, l’ho immaginato sentirsi uno scacchista nella situazione di zugzwang, in cui, al suo turno di gioco, si trova in estrema difficoltà perché qualsiasi pezzo scelga di muovere, subirà uno scacco matto. Per Remo, dunque, ritirarsi dal mondo, rimanere fermo sentendo l’impossibilità di procedere sembra essere la sua unica mossa possibile.
Altre visioni, a volte con lo stesso sguardo
Il rapporto causale tra mente e corpo rimane determinante anche negli approcci che esplicitamente osservano la loro relazione, di cui la psicosomatica ne è un esempio. Lo stress diviene agente patogeno, definito come causa capace di esercitare sull’organismo, con la sua azione prolungata, uno stimolo dannoso, provocandone di conseguenza la reazione. Lowen (2001) indica che “le malattie psicosomatiche sono così chiamate perché non vi è alcun agente eziologico specifico che ne sia responsabile in modo esclusivo”, come se là dove la scienza medica non riconosce un determinante oggettivamente identificabile, allora la psicosomatica riesce a costruire nuove rappresentazioni e spiegazioni, comunque causalmente determinate.
Per quanto estremamente interessante il contributo e l’apertura a considerare la persona non solo come una macchina banale, in questo approccio sembra rimanere invariata la prospettiva lineare, conservando, inoltre, il medesimo sguardo di moralizzazione della malattia, ampliandone i domini di osservazione, ma mantenendone il carattere colpevolizzante.
Anche la psicosomatica, presa a esempio, non oltrepassa il limite dell’approccio bio-medico, è comunque un intervento finalizzato a modificare, ridurre, espellere, correggere porzioni del sistema poco funzionante, senza liberare la persona dalla colpa di essersi ammalato, dall’insufficiente volontà di guarire a causa dello stress. Il corpo isolato dal mondo delle relazioni e delle interazioni diventa un oggetto, il meccanicismo diviene, inoltre, il “pensiero che oggettivizza il corpo, finalizza il suo comportamento verso un effetto desiderato, determina l’esperienza del fallimento nel condurre, con volontà ed esercizio, la remissione della sintomatologia fisica” (Galimberti, op. cit.).
È nel pensiero di Bateson, ripercorrendo alcuni istanti e alcuni particolari, che è espresso l’approccio sistemico relazionale su mente-corpo e su qualsivoglia dualismo. Impossibile pensare una separazione tra “corpo fisico” e “mondo mentale” o la separazione della persona dal proprio ambiente. Ogni sistema vivente è un sistema mentale e viceversa. “Ogni organismo produce se stesso in un riconoscimento auto-riflessivo; tale riconoscimento si intreccia con il contesto di vita dell’organismo in una continua spirale costruttiva, una «danza di parti interagenti»” (Bateson, 1972), il che impedisce di separare le parti e, al contrario del meccanicismo, propone di distinguere per collegare. Non c’è vita senza flessibilità e non c’è vita senza ambiente, tanto che nessuna unità può essere considerata separatamente e rigidamente: “insieme con un organismo flessibile, si deve considerare anche un ambiente flessibile […] L’unità di sopravvivenza è il complesso flessibile organismo-nel-suo-ambiente” (Bateson, ivi).
Nello sguardo di Bateson non è possibile riferirsi a un mondo mentale interno e un mondo fisico esterno, l’interconnessione tra mente-corpo e ambiente è continua e ricorsiva, molte delle informazioni che il sistema mentale riceve ed elabora sono al di fuori del confine corporeo.
Un ulteriore elemento che problematizza il rapporto causale, anche tra mente e corpo, è quello della finalità cosciente che per Bateson è quell’atteggiamento che esclude la complessità per perseguire il risultato desiderato, cercando il percorso più breve e semplice. Se si perde una visione dell’individuo connesso al contesto e a esso interrelato, la finalità risolutiva del problema rischia di divenire l’unica emergente. Per Bateson (1972) “il corpo [deve essere visto] come un sistema autocorrettivo organizzato in modo cibernetico e sistemico”, altrimenti, proprio riferendosi alla medicina, considera che si attuino solo parziali interventi per eliminare un problema, un disturbo, una malattia.
Il pensare le persone come organismi viventi significa considerarle come uniche e differenti ciascuna dall’altra, in un’inseparabile connessione col proprio ambiente invece che classificarle in gruppi omogenei e considerare le relazioni con l’ambiente esterno poco o per nulla influenti. Inoltre, se la persona è anche un’entità autonoma che, in modo dinamico, evolve nel tempo non potrà essere osservata e pensata come un oggetto statico che obbedisce a dei comandi.
Se le persone non sono più entità oggettivabili, ognuna differente dall’altra, se l’ambiente è influente, se la realtà che proviamo a conoscere è sempre parziale, se gli effetti delle relazioni sono imprevedibili e indeterminabili, in che modo è possibile conciliare questa prospettiva senza ridurre la complessità? Come, dunque, connettere tale prospettiva sistemico relazionale e la complessità con la prassi e in particolare modo con la prassi clinica e pensare di noi come macchine non banali?
La prospettiva salutogenica
Una risposta possibile, al quesito posto, è data dalla prospettiva salutogenica. Questo approccio è stato concettualizzato da Aaron Antonovsky che aveva ricevuto nel dopoguerra, dal governo israeliano, l’incarico di valutare lo stato di salute delle persone anziane in Israele. Egli andò a misurare la salute dal punto di vista fisico e psichico, nello specifico l’adattamento alla menopausa di donne di diverse etnie, tra cui anche donne sopravvissute ai campi di concentramento. Rilevò che un gran numero di esse era in buone condizioni di salute psicofisica e dotata di buone capacità di adattamento, cioè in grado di ricreare la propria vita nonostante quell’esperienza traumatica.
Ribaltando la prospettiva cominciò a indagare quali fossero i fattori e processi generatori della salute anziché ricercare le cause delle malattie. Cercando risposte a nuove domande su come le persone, in presenza di eguali condizioni avverse, restino in salute mentre altre si ammalino. Considerando l’incertezza e l’imprevedibilità degli eventi della vita come elementi naturalmente presenti, così come i fattori di stress, l’autore riconobbe la capacità degli esseri viventi di fronteggiare, adattarsi e sopravvivere a tali fattori. Per Antonovsky la salute dell’individuo diviene un concetto relativo secondo un modello di continuum tra salute e malattia che posiziona, in un determinato momento, ogni persona in un punto di questa linea. La flessibilità del modello si apre alla possibilità di modificare la descrizione nel corso del tempo, andando a ricercare quali elementi siano di supporto a favorire lo spostamento personale del punto del continuum verso il polo della salute in una ricerca delle “cause” di salute. Uno sguardo che modifica il punto di osservazione alla ricerca dei fattori individuali biologici, materiali, psicologici, relazionali, sociali e spirituali che favoriscono la salute della persona nel tempo e che considera quest’ultima come un processo dinamico dove gli individui possono sempre descrivere aree di salute indipendentemente dalla malattia. Il mio interesse per questo modello è anche dovuto al fatto che si allontana completamente dalla prospettiva lineare, infatti secondo Antonovsky: “lavorando con un orientamento patogenico si è spinti a dimenticare la complessità. […] Chi si prende cura deve essere infatti molto empatico e sensibile alla pressione di dimenticare l’essere umano che ha la malattia. Il promotore di salute, indipendentemente dalla sua inclinazione personale, è spinto a occuparsi della persona.” (Antonovsky, 1996).
Ciò descrive come l’ottica lineare dell’approccio bio-medico impedisca di riconoscere e osservare la complessità del divenire umano unico e contestuale. Il nuovo sguardo alla salute presuppone che ogni persona sia più o meno sana e più o meno malata, con l’obiettivo di riconoscere e individuare in quale modo la persona possa, sul continuum salute-malattia, divenire più sana. Con un ulteriore presupposto che in qualsiasi punto del continuum la persona si trovi potrà disporre di opportunità e risorse per muoversi verso il polo della salute.
La persona è vista come soggetto attivo e inserito in un contesto relazionale e sociale che ha la possibilità di migliorare, sempre, il suo stato di salute, in un rapporto dinamico e non staticamente definito a priori. Nel tempo la persona può accedere a risorse individuali e relazionali utili a un suo nuovo posizionamento. La salute diviene un’esperienza e una narrazione individuale che tiene conto della storia della persona ed è modificabile nel tempo, non più una riduzione o eliminazione di un sintomo o di un disturbo bensì un processo di ricerca.
Da questo punto di vista “la salute diviene un’esperienza di apprendimento permanente che porta a confrontare se stessi, la propria storia con gli eventi della vita […] ognuno portatore di una storia di salute, che necessita di traiettorie flessibili, e mai definite a priori, per apprendere le capacità di stare in equilibrio tra le varie esperienze di vita” (Garista, 2017). Dunque, un processo complesso che considera la persona interconnessa al suo ambiente in cui, inoltre, “dare forma alla propria vita significa avere cura di sé” (Mortari, 2012).
Se si vuole, quindi, descrivere un modello complesso, sarà necessario prendere in considerazione i numerosi livelli della complessità. Si interrelano aspetti differenti: la persona, il suo ambiente, il corpo fisico, la malattia e le “saluti”, che hanno a che fare con la cura di sé e con le potenzialità individuali, relazionali e sociali, con le risorse interne ed esterne del sistema umano, ogni sistema interconnesso. L’approccio salutogenico si presenta come un cambio di paradigma che supera il modello lineare che ricerca quali siano gli elementi in connessione, personali e in dialogo con l’ambiente, storici, culturali che nel corso del tempo favoriscono e determinano una condizione di benessere.
La posizione di Antonovsky è rilevante anche per la sua visione fluida dell’esistenza. Gli eventi accadono, alcuni eventi a nostro malgrado, e la possibilità di riuscire a superare anche le criticità che si presentano non risiede unicamente all’interno della persona me sempre in relazione con il contesto.
Osservare la persona nel suo ambiente permette di estendere le riflessioni sulla salute. Inoltre, l’approccio salutogenico permette di considerare lo sviluppo del divenire umano e “comporta necessariamente il ricorso ai principi della complessità” (Antonovsky, 1987). Esso tiene conto del principio di auto organizzazione dei sistemi complessi in cui un sistema biologico è un sistema autopoietico (Maturana, Varela, 1980) cioè dotato di un’organizzazione in grado di mantenere e rigenerare nel tempo la propria individualità e autonomia rispetto alle continue variazioni ambientali. La proprietà di auto organizzarsi e di rigenerarsi nel contesto spiega come la traiettoria verso il polo della salute possa essere considerata come una ricerca dinamica di equilibrio in divenire, piuttosto che una ricerca di uno stato preesistente.
In questo, l’approccio salutogenico assume un principio ricorsivo in cui gli effetti retroagiscono sulle cause. I fattori salutogenici, ovvero quelli patogenici, agiscono sulla salute e lo stato di salute retroagisce sui determinanti di salute. Il tutto in un contesto spazio temporale definito anche dalla dimensione relazionale fra passato, presente e futuro. Con un’ulteriore articolazione di livello che presuppone che tutto ciò avvenga anche tra risorse interne ed esterne, una ricorsiva azione e retroazione tra di esse. Se il divenire umano si svolge in un contesto imprevedibile e incerto, a maggior ragione la salute diviene un processo relazionale con infinite possibilità, in cui ogni modificazione delle risorse, dei fattori e delle determinanti salutogenici determineranno un effetto sull’intero sistema, anche se non è possibile sapere quale.
Al di là del sintomo: due storie
Claudio si mostra e si descrive come una persona determinata che nella vita, e anche nel lavoro che svolge, definisce degli obiettivi da raggiungere, che passo dopo passo, in un processo lento, lo portano alla vetta. Ridefinire la domanda e delineare il processo di lavoro era, per me, fondamentale a evitare di colludere con la domanda implicita che il suo percorso di psicoterapia fosse uno dei tanti appigli per raggiungere l’obiettivo di guarire dai suoi sintomi. Nel procedere delle sedute, una delle mie più grandi fatiche durante i colloqui con Claudio è stata quella di aprire a descrizioni differenti rispetto a quelle già presenti, forse già descritte, cristallizzate in spiegazioni lineari. A volte è stato persino difficile avere risposte a domande circolari e riformulare e, almeno in parte, ristrutturare le narrazioni.
Nel racconto delle modalità relazionali familiari e nell’esperienza lavorativa emerge la percezione di Claudio di essersi sentito perlopiù squalificato dal padre, che ha espresso nei suoi confronti una forte critica, giudicando negativamente anche le sue passioni. Oltre quella della montagna, nel tempo, ha coltivato in particolare modo la fotografia e la scrittura, realizzando libri per scalatori e vendendo video e fotografie naturalistiche per agenzie pubblicitarie. Anche la vena creativa non è mai stata apprezzata dal padre, anzi svalutata come una perdita di tempo. La madre non svalorizza gli aspetti creativi di Claudio ma non ne mostra nemmeno interesse.
Le sue descrizioni sembrano mostrare relazioni intra-familiari caratterizzate da modalità di squalifica e disconferma e se “essere visto significa esistere” (Cecchin, in Stübner, 2013) l’esistenza di Claudio sembrerebbe caratterizzata dal valer poco. Impossibile pensare che la colite ulcerosa sia causa o effetto di tutto ciò, ma nelle convinzioni di Claudio essa sembra essere rappresentativa, la manifestazione concreta del suo disvalore.
Remo, invece, si presenta come incapace di individuare degli obiettivi per se stesso. Esplorando le relazioni piuttosto che la ricerca delle cause del suo malessere o delle possibili soluzioni da agire, emerge un elemento interessante nell’osservazione del genogramma che fa riflettere Remo sul fatto di non voler fare la fine di una delle sue cugine, nubile, che si è occupata prima della nonna e successivamente della propria madre fino alla loro morte. Sembrerebbe esserci un’implicita ingiunzione familiare, che si ritrova in alcune tradizioni contadine, che vede gli ultimogeniti dedicarsi alla cura dei propri genitori rinunciando a realizzare una propria vita al di fuori della famiglia di origine. In terapia chiedo a Remo se può essere possibile il fratello e la sorella pensino che sia lui a doversi occupare della loro madre, mi risponde che non sa se lo pensino o meno ma che nei fatti è così. Remo sembra essere, dunque, una persona incastrata in una vita che non ha scelto, fedele alle ingiunzioni familiari di rimanere a disposizione dei genitori prima e poi sostituto marito della madre vedova. Incapace di immaginare di poterla lasciare da sola, preoccupato che senza la sua presenza possa soffrire a tal punto da lasciarsi andare verso una morte desiderata.
Nei colloqui con Claudio è sempre stata presente una sorta di velocità nel ritmo e la possibilità di offrire elementi perturbativi che venivano comunque colti, ciò mi ha permesso di sentire di procedere, amplificando la mia possibilità di fare collegamenti e proporre altri piani di osservazione ed esplorazione. Con Remo il ritmo è stato più lento, anche la numerosità delle sedute può avere a che fare con un reciproco bisogno di andare gradualmente, in una sorta di prudenza che ho sentito cogliermi e che, in alcuni momenti, mi ha messo in impasse, con un’esigenza di rispettare i suoi tempi e ritmi, con l’attenzione a muovermi con estremo tatto, nell’accezione etimologica dell’utilizzo di un senso per “giudicare certe qualità dei corpi, della loro solidità, fluidità, secchezza, temperatura”.
Dando come ulteriore cornice della terapia la domanda di cambiamento, ritengo che forse la differenza del ritmo della danza potrebbe avere a che fare con il significato che per ciascuno di loro avrebbe potuto comportare un cambiamento.
I cambiamenti nella vita quotidiana – cambiare lavoro, cambiare casa, aprirsi a nuove conoscenze – per Remo potrebbero essere stati percepiti come estremamente pericolosi. Sia per sé in una possibile prefigurazione di un fallimento, di rimanere deluso, di sentire di non riuscire a farcela e soprattutto per la mamma, per l’effetto che tali cambiamenti avrebbero potuto avere su di lei. Claudio, invece, sembrerebbe non aver nulla da perdere, aperto a rinnovarsi nel lavoro, incerto nella relazione con la sua compagna, sempre più distante dalle pressioni familiari. Credo di essere venuta in contatto con la prudenza di uno e l’audacia dell’altro nel rispetto di entrambe le posizioni, che spesso hanno fatto sentire anche me estremamente cauta con Remo e, a volte, con Claudio sorpresa di me stessa delle intuizioni o delle connessioni che proponevo.
Tutto questo sembra avere a che fare con le dimensioni della stabilità e cambiamento che caratterizza Claudio e Remo in maniera differente. Il primo sembra definire la dimensione di senso della propria vita proprio nel procedere in cambiamenti continui, nel ricercare, nelle sfide, nel rischio, nel lavoro su di sé come promotore del cambiamento. Remo, invece, sembra trovare una sua dimensione di senso nello stare, nel mantenere fermo il mondo, nello status quo.
Nel lavoro con entrambi mantengo in sottofondo le domande riguardo a sintomi, comportamenti, reazioni o quant’altro: “cosa dice della storia di questa persona? a cosa serve tutto questo?”. Le sento essere per me buone domande, che evitano di cadere in interpretazioni o ricerche di soluzioni che spesso vengono richieste dalle persone, e mi permettono di mantenere alta l’attenzione alle risorse presenti. Intendo, il più delle volte, rivolgere l’attenzione alle risorse presenti con la medesima accezione della connotazione positiva cioè “con l’intenzione di costruire una cornice narrativa che preveda vie di salvezza” (Giuliani, 2014). Con Claudio più facilmente, data la sua attitudine a ricercare nuove letture, ad aprirsi e a interessarsi a punti di vista differenti, con un’idea positiva del mondo. Anche con Remo propongo uno sguardo differente, anche opposto e connotato positivamente, che favorisca il rinarrare le sue fatiche e difficoltà come punti di valore, come generosità, attitudine positiva, come premure.
Nessuna delle decisioni prese da Remo nel corso della psicoterapia rispetto, ad esempio, la casa di proprietà che viene lasciata libera dall’affittuaria che decide di cominciare ad arredare, cominciando a immaginare di poterci andare a vivere, o un colloquio di lavoro per sperimentare la capacità di sostenerlo, sono state discusse in seduta o “prescritte” in qualche modo da me. Tagliando la zavorra che lo teneva immobile, le “prove di volo” di Remo arrivavano in terapia già decise o già sperimentate e ogni volta ne rimanevo sorpresa. In questo passo lento, ma inesauribile, il provare e lo sperimentare sono stati grandi spazi di nuove possibilità, sentendo verificarsi “la necessità non di curare o risolvere problemi quanto di essere utili, innovativi, di decostruire le storie con le quali le persone si presentano” (Telfener, 2017).
Da un certo punto di vista sono stati percorsi imparagonabili, o meglio è sempre impossibile paragonare le persone, che non sono patologie o sintomi, ogni processo terapeutico è unico; premesse, modelli, convinzioni, storie familiari, esperienze di vita sono peculiari e originali. In questo lavoro con Claudio e con Remo, che ha avuto anche momenti di sovrapposizione temporale, l’unico elemento invariabile sono stata io, ciò mi permette di riconoscere che la terapia mette in gioco una corresponsabilità, una danza che si fa in due, ciascuno con quello che ha a disposizione; con la consapevolezza della mia responsabilità in particolare modo di occuparmi del processo terapeutico ho sperimentato che lo sviluppo, l’andamento e l’eventuale esito è, anzitutto, di proprietà della persona.
Conclusioni e apprendimenti
Claudio, da scalatore esperto, mi ha insegnato la differenza tra appigli e appoggi: si appoggiano i piedi su due punti stabili per cercare nuovi appigli da raggiungere con le mani. I nuovi appigli potranno diventare appoggi, un nuovo appiglio diviene un nuovo appoggio per procedere verso la vetta. Quindi solo lasciando andare uno dei due appoggi, potrò ritrovare una nuova posizione differente dalla precedente, momentaneamente stabile e di nuovo pronta a modificarsi. Ogni appiglio è connesso alla possibilità dello scalatore, alla sua elasticità, forza muscolare, esperienza e conoscenza della montagna. Mi sembra che ciò sia paragonabile al procedere umano e anche al procedere psicoterapeutico. Esplorare e osservare i propri appoggi, le proprie premesse, idee, miti familiari, pregiudizi, modalità relazionali per esplorare nuovi appigli possibili. Nuove opportunità di cambiare la posizione presente in una postura differente, in un continuo divenire.
Nel lavoro con Remo ho fatto esperienza della fiducia nei processi evolutivi e nella relazione terapeutica. Più volte ho avuto l’impressione che nulla accadesse, che fossimo in impasse ma rimaneva presente la relazione tra noi. Lentamente, con i suoi tempi, Remo ha colto la possibilità di accedere a opportunità presenti nel suo contesto di vita, attivando in lui una capacità decisionale e di azione da tempo bloccata.
Con entrambi ho percepito che l’approccio sistemico li sollevasse dal trovare conferma che erano stati essi stessi la causa della loro malattia, che in qualche modo se la siano voluta o meritata, involontariamente o forse proprio per mancanza di volontà. Sono stata sollecitata da entrambi a fornire risposte, a proporre soluzioni, a rassicurare “dall’alto della mia conoscenza”, a prescrivere qualcosa di efficace per rispondere alle richieste di guarigione dalla malattia o sintomatologia o, per quanto riguarda Claudio, a sviluppare la consapevolezza così da poter procedere nel suo percorso di crescita personale. Una sollecitazione forte, per molti colloqui presente, che col passare del tempo è diminuita. Mi chiedo se la mia rinuncia a rispondere a questo tipo di sollecitazione abbia in qualche modo fatto da ulteriore cornice in cui Claudio abbia potuto cominciare a prendere in considerazione la possibilità di rinunciare anch’egli alla ricerca di una guarigione impossibile o al miracolo della guarigione. Questa mia posizione relazionale potrebbe aver permesso a Remo, invece, di rinunciare a guarire una malattia, che forse non esiste, per prendersi cura della dimensione relazionale della sua vita.
Il sintomo o la malattia sono stati per entrambi l’occasione o l’epifenomeno per accedere ad ampliare lo sguardo in una ricerca di senso più ampia che permettesse loro di osservare differenti connessioni ancora inesplorate, passando e ritornando dal piano fisico a quello relazionale, connettendo mente e corpo in un processo non lineare.
Le richieste di Claudio e di Remo contenevano quella che era una domanda già presente in me su cosa fosse cura e salute nella relazione corpo-mente. Nei casi presentati e in tutto lo scritto sono, dunque, inevitabilmente e autenticamente presenti le mie riflessioni e le mie premesse sul rapporto mente-corpo e su salute-malattia-benessere e sulla differenza tra curare e prendersi cura. Questo apre al racconto della danza relazionale in terapia e anche della reciprocità dello scambio, contemporaneamente interrogandosi su quali siano le proprie premesse, quelle del sistema e dei sistemi che si sta incontrando, arricchendosi reciprocamente nell’incontro.
Diviene terapeutico già proporre alla persona una visione differente da quell’immagine immobile, passiva e oggettivata. Riconsiderare il flusso della storia della persona per riappropriarsi, nel presente della seduta, del senso degli eventi del passato per aprire a differenti prospettive future. Con le premesse epistemologiche del Milan Approach, la relazione terapeutica diviene, dunque, essa stessa una possibilità di riconoscere e sperimentare la capacità umana di essere agente attivo nella relazione con il proprio ambiente. Anche rileggendo le situazioni alla luce dei pattern relazionali dei contesti in cui si è inseriti, andandone a osservare quali siano i vincoli e le possibilità, è possibile riuscire a individuare differenti occasioni e opportunità di agire un eventuale cambiamento. Il che permette anche di aumentare i punti di vista e le possibilità di trovare nuovi significati e narrazioni a quelli già conosciuti. Non più spiegazioni esaurienti che immobilizzano la persona o prescrizioni efficaci, bensì storie differenti che potrebbero anche mostrare epiloghi inconsueti o inattesi.
Nel proporre una relazione di questo tipo, in un sistema che si percepisce bloccato e passivo, anche il riconoscimento e lo sviluppo delle risorse personali e contestuali presenti diviene un processo di empowerment con cui la persona stessa si può riappropriare anche della possibilità di autodeterminazione.
Considerare la persona in modo non lineare può essere già di per sé un atto perturbativo del sistema. Può, infatti, mettere in campo la possibilità di creare una differenza, anche nel modo di agire, producendo una differenza per se stessi e nel proprio modo di porsi nell’interazione con l’ambiente. Una perturbazione di cui non possiamo prevedere gli effetti, così come impossibile controllare gli effetti dell’incremento dei livelli di complessità.
Allora il rapporto mente-corpo, oggetto di questo scritto, risuona e ricorre come arco di circuito della pratica terapeutica e della postura sistemica, indipendentemente dall’essere una terapia individuale, di coppia, familiare o di gruppo. In tutti questi contesti e indipendentemente dalla domanda, possiamo ritrovare la premessa di guardare ai sistemi umani come fossero macchine banali; il che accade ogni volta che ci viene richiesta una soluzione, ogni volta che agiamo istruttivamente, ogni volta che ci aspettiamo un preciso effetto ai nostri interventi, ogni volta che interpretiamo invece che ipotizzare, ogni volta che siamo sicuri di aver capito o facendo domande di cui conosciamo la risposta.
I percorsi psicoterapeutici presentati permettono di partire dallo stretto rapporto mente-corpo allargandosi alla riflessione a ciò che sono le premesse – di contesto, personali e professionali, epistemologiche – premesse che si incontrano nella stanza di terapia e che riguardano tutto il sistema terapeutico, su cosa sia salute, malattia, terapia, guarigione, una riflessione complessa di cosa sia cura e prendersi cura.
Ricercare e riconoscere le premesse della persona, quelle culturali e dei suoi sistemi di appartenenza, in una danza con le nostre premesse personali, culturali e professionali per esplorare il maggior numero di descrizioni possibili, nella certezza dell’incertezza.
Bibliografia
Antonovsky, A. (1987), Unravelling the Mystery of Health: How People Manage Stress and Stay Well, San Francisco, Jossey-Bass.
Antonovsky, A. (1996), “The salutogenic model as theory to guide health promotion”, Health Promotion Inernational, Vol. 11, Issue 1, pp. 11-18.
Asen, E.; Tomson, D.; Young, V.; Tomson, P. (2004), Ten Minutes for the Family. Systemic Interventions in Primary Care, New York, Routledge, tr.it. (2015), Dieci minuti per la famiglia. Interventi sistemici in medicina di base, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Bateson, G. (1972), Step to an Ecology of Mind, San Francisco, Chandler Publishing Company, tr. it (1976), Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi.
Bert, G.; Quadrino, S. (2002), Parole di medici, parole di pazienti. Counselling e narrative in medicina, Roma, Il Pensiero Scientifico Editore.
Canguilhem, G. (1996), Il normale e il patologico, Torino, Einaudi.
Ceruti, M. (2018), Il tempo della complessità, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Damasio, A. (1994), Descartes’ Error. Emotion, Reason, and the Human Brain, New York, Putnam, tr. it. (1995), L’errore di Cartesio. Emozione, ragione, cervello umano, Milano, Adelphi.
Di Lernia, F. (2008), Ho perso le parole. Potere e dominio nelle pratiche di cura, Molfetta (BA), Edizioni La Meridiana.
Foucault, M. (1963), Naissance de la clinique: une archéologie du regard médical, Paris, PUF, trad. it. (1969), Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico, Torino, Einaudi.
Galimberti, U. (1983), Il corpo, Milano, Feltrinelli Editore.
Garista, P. (2017), “L’ombrello della salutogenesi per connettere benessere e apprendimento”, Riflessioni Sistemiche, AIEMS, Roma, n.16, pp. 59-70.
Giuliani, M. (2014), “Il bambino sistemico e l’acqua sporca”, Riflessioni Sistemiche, AIEMS, Roma, n.11, pp. 163-175.
Gritti, P. (2019), “Il paradigma psicosomatico: una prospettiva relazionale”, Riflessioni Sistemiche, AIEMS, Roma, n. 21, pp. 124-136.
Lingiardi, V. (2018), Diagnosi e destino, Torino, Einaudi Editore.
Lock, M.; Scheper-Hughers, N. (2006), Un approccio critico-interpretativo in antropologia medica. Rituali e pratiche disciplinari e di protesta, pp. 149-194, in Quaranta, I. (ed.), Antropologia medica. I testi fondamentali, Milano, Raffaello Cortina.
Lowen, A. (2001), The voice of the body. The role of the body in psicotherapy, tr. it. (2009), La voce del corpo. Il ruolo del corpo in psicoterapia, Roma, Astrolabio.
Maturana, H.; Varela, F. (1980), Autopoiesis and cognition, Reider, Dordrecht, tr. it. (1985), Autopoiesi e cognizione, Venezia, Marsilio.
Mortari, L. (2012), “La relazione di cura”, Riflessioni Sistemiche, AIEMS, Roma, n. 7, pp. 62-70.
Selvini Palazzoli, M.; Boscolo, L.; Cecchin, G.; Prata, G. (1988), Il problema dell’inviante alla terapia familiare, in Selvini, M. (a cura di), Cronaca di una ricerca, Roma, La Nuova Italia Scientifica, pp.201-209.
Sontag, S. (1977), Illness as Metaphor, New York, Farrar, Straus and Giroux, trad. it (1979), Malattia come metafora, Torino, Einaudi.
Stübner, B. (2013), “Minimal Cues”, Riflessioni Sistemiche, AIEMS, Roma, n.8, pp. 134-142.
Telfener, U. (2012), “Sul concetto di cura e su quello che facciamo in psicoterapia”, Riflessioni Sistemiche, AIEMS, Roma, n. 7, pp. 191-202.
Telfener, U. (2017), “Ricordando il passato, immaginando il futuro: l’interazione come cardine della prassi terapeutica”, Connessioni, Rivista telematica del CMTF, n.1.
von Foerster, H. (1987), Sistemi che osservano, Roma, Astrolabio.





