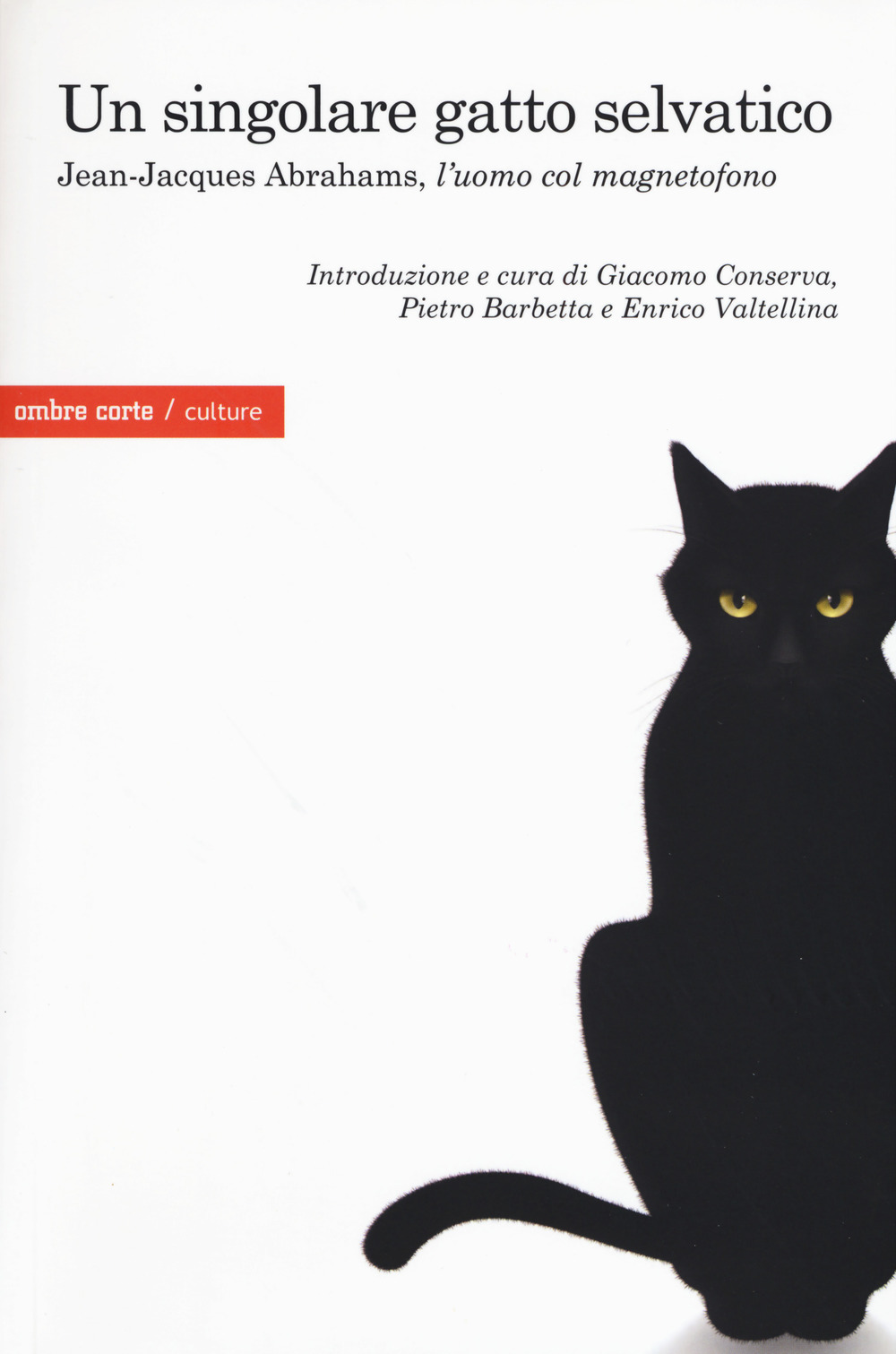
Libro a cura di G. Conserva, P. Barbetta, E. Valtellina
Editore Ombre Corte, 2017
Letto da Massimo Giuliani
La storia da cui parte tutto, il dispositivo narrativo, è semplice e, se fosse inventato, sarebbe geniale. Jean-Jacques Abrahams (giovane avvocato ebreo, uomo colto e brillante) introduce nello studio del suo analista, il dottor Van Nypelseer, che frequenta da parecchi anni, un magnetofono: intende dire delle cose e registrarle, e registrare anche la risposta dello psichiatra, ma quest’ultimo si oppone e cerca di ricondurre il paziente al rispetto delle regole e dei ruoli rispettivi. O Abrahams metterà via l’apparecchio, o la seduta si interromperà lì. Volano parole grosse, minacce di internamento e di ricorso alla forza pubblica. Un anno dopo (siamo nel 1968), fuggito dal reparto psichiatrico dell’ospedale Brugmann di Laken, Abrahams scrive alla rivista Les Temps Modernes per proporre la pubblicazione del testo.
Comunque la si voglia vedere sull’atto deflagrante di Abrahams (il libro rende conto anche della profonda frattura fra il giudizio di Sartre da una parte, e quello di Pontalis e Pingaud dall’altra), quella concitata conversazione ci riguarda. Perché il suo tema è la responsabilità (quello scambio, fuori dalle mura dello studio, diventa qualcosa di cui rispondere); perché in quella stanza di analisi va in scena un’insubordinazione che mette in questione un rapporto di potere; perché nella questione se sia da considerare violenza fisica il telefono rovesciato sul pavimento dal paziente (cos’è successo prima che partisse la registrazione?) più dell’obbligo che egli ha subìto per anni di voltare le spalle all’analista, c’è una domanda che riguarda chiunque lavori con un’idea normativa di gestione dei corpi nel setting clinico (non c’è solo il lettino: c’è lo specchio unidirezionale, per dirne una).
Il paziente giudica il sapere del medico (“Lei d’altra parte non è pronto ad assolvere i suoi obblighi perché non sa guarire la gente; lei non sa che renderla un poco più pazza”) e quest’ultimo, alle corde, brandisce il proprio sapere per aprirsi una via di fuga da una situazione assai complicata (“Lei è pericoloso perché misconosce la realtà!”; al che: “Non sono pericoloso; alzo solamente la voce, ma lei non lo sopporta; se grido ha paura, non è vero?”).
Il doppio legame nel quale è stretto il povero dottore (e al quale si deve la drammaticità del dialogo) consiste nel fatto che se prende sul serio le parole del paziente infuriato, deve ammettere l’inutilità del proprio operato e la vacuità del proprio potere; ma mentre le stigmatizza come folli, dichiara di fatto il fallimento (l’inganno?) di anni e anni di cura (a due o tre sedute alla settimana). “Non sta che raccogliendo ciò che ha seminato”, lo ammonisce Abrahams.
Proprio come il magnetofono nella stanza, il testo di Abrahams irruppe nel dibattito psicoanalitico alla maniera di un “singolare gatto selvatico”, secondo la definizione di Fachinelli.
Così il volume si articola in tre parti: la prima contiene il celebre sbobinato e alcuni commenti di intellettuali che si interessarono alla vicenda (Sartre, Pontalis, Pingaud, Fachinelli, da un numero della rivista L’erba voglio del 1977); nella seconda ci sono alcuni scritti odierni sulla vicenda (di Naninga Lens, Pietro Barbetta, Giacomo Conserva, Antonello Sciacchitano, Alfredo Riponi, Lea Melandri); nella terza, infine, altri scritti di Abrahams più uno di Laura Erber su Sophie Podolski che getta luce sul quadro culturale nel quale Abrahams compì il suo gesto e lo rese noto.
Quadro culturale, e politico, e sociale (il dibattito si apre a partire dal 1968, ricordiamolo), che percorre tutto il libro ed è rievocato da molti degli autori che riflettono sulla vicenda. Pietro Barbetta, giustamente, osserva che il registratore è diventato da quegli anni una presenza persino familiare nella stanza di terapia (attraverso il lavoro di Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin e Giuliana Prata, e poi anche di psicoanalisti interessati allo studio della conversazione) e abbia disintegrato il dogma del carattere privato della terapia. Se il libro rievoca la disobbedienza di Abrahams, esso si eleva a metafora della questione del rapporto fra cura e potere (ma anche fra cura e poteri).
Naninga Lens si sofferma sulla biografia di Abrahams e sulla vicenda del “gatto”, dando conto anche del dibattito fra Sartre e Pontalis. Barbetta inquadra la storia nel periodo in cui si svolge, e si occupa della figura di Elvio Fachinelli. Conserva ne offre una lettura filosofica acuta, che passa attraverso Platone (il mito della caverna) e la mistica ebraica. Sciacchitano parla di tutti gli “uomini col magnetofono” senza magnetofono, e della “paranoia post-analitica” comune ad analizzante e analista. Riponi si muove sulla coordinata Abrahams – Beckett (intorno all’apparecchio riproduttore della voce umana si svolge la vicenda del beckettiano Krapp). Infine, quanto mai a proposito, Lea Melandri rievoca gli anni della rivista L’erba voglio.
Seguono, come già detto, gli scritti successivi di Jean-Jacques Abrahams, attraversati da una riflessione su immagine e linguaggio, sul guardare e l’ascoltare, che culmina nell’omaggio finale all’invenzione dei fratelli Lumière, dal titolo che più esplicito non si può: “Che si fotta il sonoro”.





