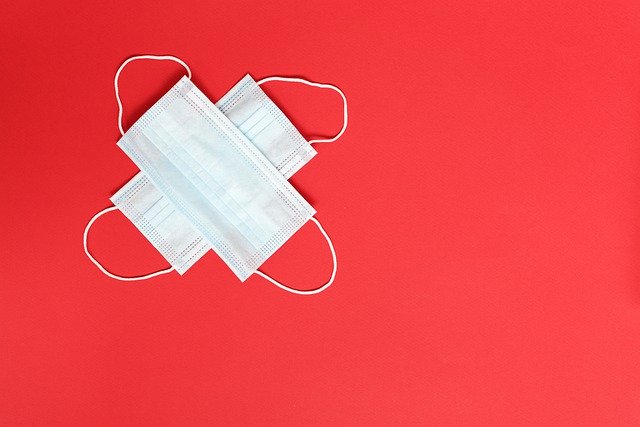
nastya_gepp (CC0), Pixabay
Le esperienze degli allievi delle Sedi della Scuola nella pandemia e nel post
a cura di Ada Piselli e Barbara Trotta
Quando la casa non è sicura
Giulia Mondolo, CPTF, II anno
Dall’approvazione del Dpcm del 9 marzo 2019, riguardante le misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, ai cittadini italiani è stato richiesto di rimanere quanto più possibile nelle proprie case, evitando spostamenti non necessari; questo ha dato immediatamente il via ad una serie di campagne ministeriali e non con protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, ripresi nelle loro abitazioni intenti in svariate attività, mentre invitano i cittadini a fare la loro parte per evitare l’ulteriore diffondersi del virus. L’intento è subito intuibile: promuovere comportamenti virtuosi attraverso l’imitazione dei modelli.
Il messaggio che passa è che quella contro il Covid-19 è una vera e propria guerra, nuova nelle sue modalità, e ci viene richiesto di combattere dalla sicurezza delle nostre case. Nell’immaginario collettivo la casa è il luogo in cui ci rifugiamo per proteggerci dai pericoli provenienti dall’esterno. Fin dalla prima infanzia, attraverso le favole come ad esempio quella dei tre porcellini, viene insegnato ai bambini un’associazione importante tra il “dentro-sicuro” e il “fuori-pericoloso”, viene detto loro che nella vita basta avere una casa abbastanza solida, assicurarsi di aver chiuso la porta ed evitare di far entrare gli sconosciuti per proteggersi dalle minacce. Dopo tutto, Biancaneve è caduta addormentata dopo aver trasgredito l’ordine dei suoi amici nani ed essersi fidata dell’estranea che aveva bussato alla sua porta per offrirle una mela, e anche i sette capretti non sarebbero stati vittime della voracità del lupo se avessero dato ascolto alla loro madre e non avessero aperto la porta di casa in sua assenza. La stessa Sirenetta, nella fiaba originale, scritta da Andersen, si sarebbe risparmiata la trasformazione in schiuma di mare se fosse rimasta al sicuro nel suo regno in fondo al mare.
In inglese esistono due parole per riferirsi alla casa: “house” e “home”. Il primo termine identifica l’abitazione fisica, mentre il secondo rispecchia le implicazioni psicologiche di casa, intesa come ambiente familiare ed affettivo, spazio vitale da vivere da soli o da condividere, che permette l’espressione di sé e fornisce protezione. In italiano, ci si riferisce alla seconda attribuzione con l’espressione “sentirsi a casa”, che ha a che fare con il sentirsi “comodi”, a proprio agio nel contesto in cui si è inseriti.
Ma cosa succede se ti accorgi di aver sposato l’orco cattivo delle favole? Se la bestia alla fine della favola non si trasforma come per magia nel principe azzurro? In quel caso dove ti rifugi? Per molte donne l’aggressore non è un estraneo, ma condivide il loro stesso letto e passare questo periodo di isolamento forzato equivale a mettere un anello in più alla catena che le tiene legate ai loro aguzzini.
Chi lavora all’interno dei centri antiviolenza sa bene che queste donne non hanno bisogno di una fatina che le aiuti con un colpo di bacchetta a risolvere i loro problemi, quanto piuttosto di un “aiutante” che le accompagni passo dopo passo a essere protagoniste della loro storia. A partire dal 23 febbraio di quest’anno, quando le restrizioni comunali hanno reso impossibili gli incontri in persona, al Centro Antiviolenza di Padova si è lavorato sin da subito per contattare le donne seguite, rassicurandole che non sarebbero state lasciate sole a combattere la loro battaglia, lasciando aperta la possibilità di uno spazio telefonico per coloro che ne avessero sentito la necessità e di accoglienza nei casi più gravi. In un momento come quello del lockdown, rispetto all’incubo di trovarsi in casa con il proprio orco e non avere possibilità di fuga, si è lavorato perché si riducesse quanto possibile il senso di isolamento, consapevoli del fatto che l’avere una rete d’appoggio esterna costituisca un fattore imprescindibile per agevolare la fuoriuscita dalla violenza.
Sono state previste delle campagne informative sulle pagine social del Centro rivolte non solo alle donne che vivono una relazione abusante, fornendo loro dei suggerimenti pratici su come mettersi in contatto con il Centro Donna in un’ ottica di salvaguardia della loro incolumità (es. compilando il form anonimo presente sul sito, avendo l’accortezza di cancellare la cronologia o chiamare con il proprio smartphone il numero verde aspettando il momento in cui si esce per fare la spesa, per buttare l’immondizia o per andare in farmacia), ma anche volte a sensibilizzare coloro che, vivendo in prossimità di una donna vittima di violenza, possono essere delle risorse nel sistema, per fornire informazioni utili e un rifugio sicuro in caso di minaccia. Queste campagne sono state tradotte in diverse lingue (es. rumeno, arabo, inglese ecc.) per rispondere alle esigenze anche delle donne straniere nelle relazioni di abuso, che ad oggi costituiscono il 27% circa delle utenti prese in carico dai centri antiviolenza. Tenendo presente le particolari resistenze delle donne migranti nel rivolgersi alle istituzioni dovute alle barriere linguistiche, alla mancata conoscenza dei loro diritti nel paese ospitante o alla diffidenza, spesso dovuta a esperienze negative con le forze dell’ordine, risulta quanto mai importante ridurre il loro senso di isolamento fornendo indicazioni che siano accessibili nella loro lingua madre.
Nonostante le differenze culturali, è possibile fare riferimento alle statistiche sull’aumento dei casi di violenza denunciati in Cina dopo la fine del lockdown, più che raddoppiati nella provincia di Hubei, per ipotizzare una situazione analoga anche nel nostro Paese con l’inizio della fase 2. Nei primi mesi dall’inizio delle restrizioni i contatti al Centro Antiviolenza di Padova hanno subito drastiche riduzioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, così come analogamente è successo in tutta la penisola. Si è reso più che mai necessario, in questa emergenza sanitaria, creare una prossimità con queste donne attraverso nuovi mezzi (social, app) per evitare che l’isolamento si trasformasse in un senso di abbandono e di sfiducia nel sistema e le convincesse ad evitare di combattere la loro battaglia.
Bibliografia
Chen, T. (2016), China’s First Law Against Domestic Violence: It’s No Longer a Private Matter. https://asiafoundation.org/2016/01/20/chinas-first-law-against-domestic-violence-its-no-longer-a-private-matter/ (acc. 6/20).
Felson, R.; Messner, S.; Hoskin, A.; Deane, G. (2002), “Reasons for reporting and not reporting domestic violence to the police”, Criminology, 40:617-647.
Graham-Harrison, E. (2020), Lockdowns around the world bring rise in domestic violence, https://www.theguardian.com/society/2020/mar/28/lockdowns-world-rise-domestic-violence (acc. 6/20).
Lanier, C.; Maume, M. O. (2009), “Intimate partner violence and social isolation across the rural/urban divide”, Violence against women, 15(11), 1311-1330.
Menjívar, C.; Salcido, O. (2002), “Immigrant women and domestic violence: Common experiences in different countries”, Gender & society, 16(6), 898-920.
Ministero della Salute, http://www.salute.gov.it
Istat, Il numero delle vittime e le forme della violenza, https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza (acc. 6/20).
Zhang, W. (2020). Domestic Violence Cases Surge During COVID-19 Epidemic. https://www.sixthtone.com/news/1005253/domestic-violence-cases-surge-during-covid-19-epidemic (acc. 6/20).
Fronteggiare un’emergenza sanitaria: modi diversi per scoprirsi insieme
Marta Guidotti, CMTF, II anno
Lavoro come psicologa in una cooperativa all’interno di un progetto SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati). Dal 2018 possono fare domanda d’ingresso nel progetto solo le persone che hanno ottenuto il riconoscimento della protezione internazionale. Il progetto, ad alta autonomia, prevede (per una durata variabile da sei mesi a due anni circa) l’accoglienza in appartamenti condivisi e dislocati nel territorio e diversi servizi tra cui: sostegno economico, corsi d’italiano, orientamento e formazione professionale, supporto legale e psicologico.
Mi occupo di adulti, spesso molto giovani. Sono uomini e donne che arrivano in Italia dopo viaggi estenuanti e traumatici durati anche diversi anni da quando hanno lasciato la propria terra e le rispettive famiglie. Chi parte dall’Africa ha fatto esperienza dei viaggi in zone desertiche e pericolose ed è arrivato nei lager libici e ha, infine, affrontato i naufragi nel Mediterraneo. Chi parte dall’Asia attraversa via terra almeno una decina di frontiere, percorrendo spesso centinaia di chilometri a piedi con la possibilità di essere detenuto e maltrattato a ogni passo. In tutti questi percorsi la violazione dei Diritti Umani è il pane quotidiano. Anche grazie alla complicità e al silenzio dei paesi europei.
Ognuno porta con sé la propria storia, unica e irripetibile. Spesso sono storie che raramente verranno raccontate e, ancora meno, ascoltate. Nella grande maggioranza dei casi, è presente un fortissimo vincolo con le famiglie e le comunità di origine: è un imperativo molto profondo quello di riuscire a mandare dei soldi a casa o, nel migliore dei casi, ottenere un ricongiungimento familiare. Il tema economico e il rispetto di questa lealtà comunitaria permeano le comunicazioni con i parenti e i sentimenti legati ad essi.
L’équipe è composta da operatori e operatrici con professionalità e origini culturali diverse e ricche. È un gruppo consolidato da tempo, mentre io ne faccio parte da poco meno di un anno. Dal 9 marzo decidiamo che chi non è direttamente coinvolto nell’operatività del servizio, svolgerà il proprio lavoro da casa. Organizzo il materiale da portarmi via e una parte di me fa ancora fatica a capire fino in fondo che sarà una situazione più lunga del previsto.
Nei giorni seguenti mi sono ritrovata a casa, lontana dalle persone che seguo e dai colleghi che, invece, hanno continuato a svolgere gran parte del loro lavoro nelle case del progetto. Ero preoccupata, lo eravamo un po’ tutti in équipe: bisognava far fronte a una grossa modifica delle modalità di relazione tra operatori e utenti del progetto (basate moltissimo sulla compresenza), ma bisognava anche controllare il rispetto delle norme di sicurezza e prevenire l’insorgere di gravi conflitti tra coinquilini e l’acuirsi delle sofferenze psicologiche.
Che cosa avrebbe comportato questa condizione di reclusione obbligata? Quali vissuti traumatici avrebbe rievocato? Come sarebbe stato possibile mantenere un equilibrio psicofisiologico senza le attività quotidiane all’esterno e i ritmi scanditi e rassicuranti? Cosa ne sarebbe stato delle aspettative del proprio progetto migratorio che trova prove tangibili negli impegni formativi e lavorativi, ora interrotti a data da destinarsi?
Non potevamo avere risposte certe, ma sapevamo che il fattore temporale sarebbe stato determinante. Avremmo potuto osservare una buona tenuta di tutti gli attori del sistema, ma quanto a lungo? Temevamo di dover fronteggiare un’emergenza nell’emergenza. Inoltre, le difficoltà che potevano riscontrare i nostri utenti potevano colpire allo stesso modo anche noi operatori.
Personalmente, stando anche fisicamente in un’altra città, sentivo venir ancora meno il mio senso di efficacia. Ero anche combattuta tra il volermi tutelare il più possibile in casa e l’essere disponibile come i miei colleghi che, invece, dovevano essere più coinvolti con l’operatività in loco. Nei primi tempi, ho avuto la percezione che ci fosse anche poco tempo per studiare, interrogarsi approfonditamente e, soprattutto, ascoltarsi. Sentivo da più parti una grande corsa all’azione, anche un po’ disordinata. E anche io ero un po’ in affanno.
Come équipe ci poniamo l’obiettivo di manifestare in diverse modalità la nostra presenza, vicinanza e ascolto in modo ancora più frequente e dedicato. In una condizione di allarme e spavento, dovevamo usare una comunicazione corretta, chiara e rassicurante, ma non solo: si faceva necessario mettere ognuno in condizione di sentirsi utile e padrone della situazione, per quanto possibile. Ecco che il rispetto delle norme di sicurezza diventa un modo per agire sul mondo, per compiere un gesto di cura per sé e per gli altri. Abbiamo pensato che questo letargo obbligato non doveva rappresentare un completo arresto della propria vita e del progetto migratorio ma, anzi, poteva essere vissuto come l’opportunità per consolidare le competenze che poi sarebbero state utili per la ripresa lavorativa e formativa. Ci sembra importante che quella fiamma vitale, spesso già affievolita nel corso dei passati più dolorosi, non perda troppa forza.
Così, i corsi d’italiano, e non solo, si trasformano in videolezioni con la propria insegnante, si creano diverse strategie per lo studio autonomo e guidato. L’appuntamento delle lezioni diventa centrale nella quotidianità delle case. Nasce il tempo e l’interesse per curare piccoli orti sui balconi, si iniziano a guardare film in italiano a chiedere dei libri in prestito e a conoscersi un po’ di più. Cos’altro ci avrebbe tenuto uniti e forti in queste condizioni? Vediamo emergere maggiore solidarietà tra i coinquilini del progetto. In modo inaspettato e autogestito, i turni delle pulizie vengono ora rispettati, si cucina assieme, ci si allena in casa, non si litiga per la tv ma si scelgono di comune accordo i film da vedere. Quando non compare questa grande condivisione, sorge comunque un atteggiamento di maggiore accettazione per il vicino di stanza fino ad allora ignorato, mal sopportato o detestato. È forse l’angoscia che favorisce l’emersione di un maggiore bisogno di affiliazione?
Da un giorno all’altro, passo dai colloqui in presenza alle videochiamate/telefonate. Ma sono titubante: con le difficoltà della lingua riusciremo a capirci senza stare in vis à vis? Come farò a servirmi dell’ascolto del non verbale e dell’uso del corpo che spesso mi vengono in aiuto quando l’emotività è troppo alta e non permette di andare avanti? E i colloqui con i mediatori culturali saranno troppo complicati da organizzare? Le persone avranno voglia di rispondere e usare quei preziosi giga del telefono per i nostri colloqui? E poi, non nascondo a me stessa che sono io in primis a sentirmi un po’ a disagio al telefono. Imparerò a sentirmi comoda.
Riscontro fin da subito una buona aderenza a questo nuovo tipo di contatto. Forse perché sono tutti a casa col telefono in mano e con una buona dose di noia addosso, ma, se così fosse, sembra giocare a nostro favore! Infatti, anche chi era più restio a venire agli appuntamenti si racconta con maggiore scioltezza, le parole scorrono più generose. Forse si percepisce maggiore interesse e cura per l’altro, ci si sente più pensati? Anche noi operatori e le nostre famiglie siamo tenuti più a mente: “com’è la situazione da voi a Bologna?”, “i tuoi genitori come stanno?” sono domande semplici, ma che non ci erano state spesso rivolte.
Non è poi così strano, anche loro come emigrati hanno sperimentato una forte inversione nelle dinamiche relazionali. Per la prima volta, dopo diversi anni, sono le famiglie di origine a chiamare preoccupate per la salute dei propri parenti in Italia. Interi villaggi organizzano preghiere per l’Italia; la madre di N. s’incarica del sacrificio di una vacca per far smettere l’emergenza in Italia dove risiede suo figlio, la zia di M. gli invia radici e cortecce per rinforzare il sistema immunitario, la pressione per l’invio dei soldi a casa sembra placarsi. Adesso sono loro a cui è concesso ricevere le attenzioni e le cure dei parenti, quando normalmente sono quelli incaricati di far fronte alle richieste di aiuto economico a casa e a sentirsi fallaci per non riuscire a mandare mai abbastanza. Non so se sia successo prima, ma sia io che le persone che seguo siamo rimasti commossi e sorpresi nel vedere una risposta così empatica dal continente africano verso l’occidente bianco. Non credo che questa sorta di “inversione” della cura nelle relazioni tra emigrati e chi è rimasto in patria sarà duratura, d’altra parte, non potrebbe esserlo. Tuttavia, spero che l’esperienza fatta possa essere qualcosa di positivo nel mezzo di un processo molto complesso, che è quello di far convivere la sopravvivenza e la stabilizzazione dell’individuo in esilio e i sentimenti di profonda lealtà e di assunzione di responsabilità nei confronti delle famiglie di origine.
Adesso posso dire che le preoccupazioni qui esposte sono state in parte superate, ma non sono state inutili. Mi hanno permesso di interrogarmi di più e di avere più coraggio nel lavoro che faccio e che facciamo come équipe, ma soprattutto di avere fiducia nelle risorse e nelle riorganizzazioni che i sistemi creano, soprattutto se si prepara il contesto relazionale più favorevole. Le difficoltà non sono finite, la riapertura presenta ancora più interrogativi e sfide, ma possiamo affrontarla con la sensazione di essere capaci di fare ognuno la propria parte, ma tutti insieme.
Nel ricordo di questo periodo, non mancheranno le preziose lezioni al CMTF, la disponibilità dei colleghi e la vicinanza con gli amici-colleghi con cui, in vari contesti, ci siamo confrontati e supportati.
Riflessioni su Covid-19 e vita nelle comunità terapeutiche a bassa soglia
Elisabetta Pellegatta, CPTF, II anno
Cambiare, passare cioè da una condizione ad un’altra, è un aspetto che pervade ogni atto della nostra vita; a volte è voluto e desiderato, come il passaggio da una vita individuale a una vita di coppia o familiare, altre volte è inatteso e improvviso, come l’arrivo di una calamità naturale, o in questo preciso momento di una pandemia, che in pochi istanti porta le persone a passare da uno stato in cui avevano tutto a uno stato in cui si ritrovano a non aver più niente, le proprie libertà individuali sono le prime a venir meno.
Non sempre per tutto ciò che accade o si modifica c’è una spiegazione. Noi, come individui abbiamo però un innato bisogno di sapere il perché delle cose, di creare un senso e un ordine anche laddove questo non esiste. Siamo portati quindi a creare una risposta che, anche se errata, sarà sempre più accettabile della possibilità di ammettere di essere in balia dell’ignoto, di non avere spiegazioni e risposte. Ecco nascere così teorie complottistiche, spiegazioni politiche, laboratori, ecco comparire pipistrelli e topi, untori e caccia alle streghe; ognuno si crea la propria personale risposta al perché un virus tanto piccolo e invisibile sia riuscito a cambiare radicalmente le nostre vite, ci abbia chiusi in casa, ci abbia portato a non abbracciarci più e ad essere spaventati e diffidenti verso il prossimo, ci abbia portato a perdere all’improvviso persone care senza avere la possibilità di salutarle per un’ultima volta. Non so se queste spiegazioni siano giuste o sbagliate, e non credo nemmeno sia questa la sede per fare questa analisi, credo tuttavia che sia stato naturale e insito nella natura umana cercare di provare a mettere un po’ d’ordine in un momento della nostra vita e della nostra storia dove è il disordine a padroneggiare.
La riflessione che mi viene da fare a fronte di queste premesse si lega alla constatazione che in tutta la storia della scienza la domanda “perché?” sia sempre risultata fondamentale e per certi versi anche funzionale al progresso e all’evoluzione delle scoperte scientifiche. Chiedersi il perché delle cose è da intendersi nell’accezione di ricercare continuamente una risposta in grado di spiegare ogni questione, tuttavia il rischio è che questa risposta sia condizionata e quindi anche limitata, dai nostri schemi logici rigidi, dai nostri modi di vedere e leggere le situazioni sulla base delle nostre esperienze, vissuti e storie personali. Siamo in altre parole portati a ricercare risposte coerenti con la nostra logica e il nostro modo di vedere il mondo e ciò ci impedisce di abbracciare una prospettiva elastica, non rigida e con maggiori possibilità percettive e reattive.
A fronte della nostra logica e delle nostre esperienze vissute per la maggior parte di noi è più che naturale spiegarsi le conseguenze della pandemia da Covid-19 nei termini di catastrofe, caos, cambiamento di stile di vita, ma siamo proprio certi che per tutti sia così?
Per rispondere partiamo da un’altra domanda: “cosa intendiamo quando parliamo di caos o disordine? Bateson, nel metalogo “Perché le cose finiscono in disordine?” (Bateson, 1976) aiuta la figlia a dare una definizione di disordine cambiando la domanda da porre: “perché le cose finiscono in qualcosa che Cathy chiama non-ordine?… perché se “ordinato” vuol dire per me una cosa speciale, allora certi “ordini” delle altre persone mi sembreranno disordini… anche se siamo d’accordo sulla maggior parte di quello che chiamiamo disordini…”.
Cambiando la domanda Bateson introduce il concetto di soggettività insito nella parola “ordine”, in altre parole ciò che per qualcuno può essere disordinato per altri può essere ordinato.
Calando questo concetto nella situazione odierna si potrebbe dire che ciò che per qualcuno sta risultando essere una condizione difficile da sostenere, una condizione “disordinata”, fuori dall’ordinario, ed intendo con questa condizione tutte le restrizioni alle nostre libertà che ci sono state imposte dal governo per cercare di salvaguardare noi stessi e tutti gli altri da questa pandemia del Covid-19; per altri, per una piccola ma reale percentuale di individui, si tratta di una condizione ordinaria, quotidiana, “ordinata” per riprendere i termini di Bateson.
Non voglio in nessun modo banalizzare un evento che sicuramente farà la Storia, e che avrà forti e significative ripercussioni in tutti gli ambiti della vita di tutti, a livello mondiale; voglio solo provare a portare un punto di vista differente, esito della mia esperienza professionale all’interno di una comunità terapeutica che si occupa di soggetti a “bassa soglia”, cioè adulti, uomini e donne, in situazione di estrema difficoltà (tossicodipendenti, ex carcerati e senza fissa dimora). Mi riferisco a loro in questa mia riflessione, ma non credo purtroppo siano gli unici a vivere questa realtà.
In questi giorni di quarantena la vita all’interno della comunità è pressoché invariata: tutti gli ospiti restano in struttura, hanno le loro attività quotidiane da svolgere, le loro piccole o grandi discussioni da fare, le loro chiacchierate con gli operatori. L’unica cosa che forse un po’ è cambiata è circoscritta ai pochi che con impegno e fatica erano riusciti ad ottenere un inserimento lavorativo e si stavano da poco cimentando nel mondo “esterno”, “reale”.
Tutto è stato bloccato anche lì, ma non l’hanno vissuta particolarmente male, un po’ di rabbia iniziale c’è stata, qualche malumore ma rapidamente si sono adattati alla situazione.
La logica del senso comune dettata dai molti pregiudizi insiti nella nostra natura di esseri umani potrebbe portare in molti ad affermare “Beh, non vogliono lavorare, non hanno voglia di fare nulla se non di drogarsi”. Forse per alcuni di loro può essere anche vicina alla realtà questa affermazione, ma non per tutti, non per la maggior parte di loro. Sono persone che hanno toccato il fondo, che hanno sbagliato ripetutamente nella loro vita, che hanno fatto scelte sbagliate le cui conseguenze stanno scontando tutt’ora. Non hanno famiglie che si interessano a loro, non hanno casa o posti dove andare al di fuori della struttura, ma non si lamentano di questo, anzi si aprono e si raccontano con difficoltà quasi come a non voler far trasparire le loro fragilità e le loro debolezze; preferiscono restare ben nascosti e protetti dietro la corazza del “cattivo ragazzo o cattiva ragazza” che si sono costruiti negli anni. Stanno avendo la loro ultima possibilità di riscatto all’interno di questa struttura, tutti loro ne sono consapevoli, per cui chi è fortunato e ha avuto, dopo mesi di ricerca, una prima possibilità lavorativa ne è molto orgoglioso, ha voglia di rimettersi in gioco e dimostrare in primis a se stesso di aver ancora valore e dignità.
Come mai quindi si sono adattati così facilmente alla situazione? Perché di fatto per loro poco è cambiato. La maggior parte di loro viene da altri percorsi comunitari più rigidi, in cui non avevano molte libertà di movimento: non uscivano dalle strutture, non avevano telefoni, avevano razionate anche le sigarette; la maggior parte di loro ha avuto periodi più o meno lunghi in cui ha vissuto per strada, senza un posto dove poter andare, senza un letto per riposarsi, una doccia per lavarsi. Tutti loro hanno sperimentato e continuano a sperimentare l’assenza degli affetti, delle relazioni umane, pochi di loro sanno cosa significa abbracciare o voler bene, perché non lo hanno mai vissuto sulla loro pelle. Tutti loro sono stati additati come “untori”, allontanati, emarginati. La situazione che tutti noi ci siamo ritrovati a vivere a causa del Covid-19 per loro è normalità, quotidianità. Il sentirsi privati e deturpati delle loro libertà individuali è un’esperienza e un vissuto che li ha quasi costantemente accompagnati nel corso delle loro vite.
Qualcosa tuttavia sta cambiando, sta cambiando almeno per loro la logica su cui si basano per trovare le risposte, se prima tutte le loro spiegazioni erano riconducibili alla tematica della responsabilità o assenza di valore individuale, ora la spiegazione assume un focus esterno, è attribuibile al Covid-19. È un grandissimo e importantissimo cambiamento di prospettiva per loro, se vogliamo possiamo anche considerarlo come un primo e piccolo passo verso un processo di cambiamento terapeutico. Come più volte mi è stato detto dai miei docenti della scuola di specializzazione, l’inizio del processo terapeutico avviene quando metaforicamente in una stanza entrano pecore bianche e pecore nere, buoni e cattivi, paziente designato e sistema in cui è inserito, e ne escono tutte pecore grigie. Per chi è inserito nelle comunità a bassa soglia sta avvenendo in un certo senso questo processo, per la prima volta si trovano ad essere nella stessa condizione di tutti gli altri, a sperimentare gli stessi vissuti, le stesse angosce e le stesse restrizioni. Detto questo, la mia domanda volutamente provocatoria è: se ci riescono loro a sopportare tutto questo da una vita, perché non possiamo riuscirci anche noi, per un periodo di tempo che ancora non sappiamo, ma sicuramente più breve di una vita intera?
Bibliografia
Bateson, G. (1976), Verso un’ecologia della mente, Milano, Adelphi Edizioni.
Distanti, ma connessi. Un’esperienza di lavoro con i bambini
Francesca Pizzasegola, CMTF, I anno
Viktor Frankl sosteneva che “quando non si può cambiare la situazione, non resta altro da fare che cambiare noi stessi”. Siamo davvero cambiati, da quel non troppo lontano, 9 marzo? Il contesto in cui stiamo vivendo sta innegabilmente mutando. Le vite di lavoratori, genitori, professionisti e famiglie sono state travolte dalla presenza del COVID-19. Anche la quotidianità dei bambini ha subito drastiche trasformazioni: i piccoli non hanno più potuto varcare le porte della propria scuola o incontrare gli amichetti della loro età. Troppo pericoloso, troppo rischioso. Nonostante la giustificata allerta, ad ogni modo, i bambini sono diventati invisibili, come dimenticati.
Dopotutto, come sosteneva Gregory Bateson, “la saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza”.
Ho ventisette anni e lavoro per una cooperativa sociale che si occupa, principalmente, di sostegno educativo e scolastico.
A partire dal mese di maggio sono stati proposti interventi, presso il domicilio dei bambini e delle loro famiglie, dedicati soprattutto ai più piccoli. Per quanto riguarda i ragazzi più grandi, invece, è stato concesso di poter vederli, parlargli e sostenerli unicamente tramite videochiamate.
Negli ultimi due anni ho seguito due ragazzini, di dodici e tredici anni, mediante un progetto di assistenza domiciliare. È arduo provare a descrivere le loro espressioni o il loro sguardo quando, dopo due mesi di isolamento, finalmente è stato concesso, dal comune della loro città, di proseguire gli incontri con me tramite videochiamata. La prima volta che mi hanno rivista, dietro uno schermo, pareva si trovassero di fronte una persona a loro sconosciuta. La loro vivacità non c’era più, gli occhi erano spenti. Ora, dopo quasi due mesi, le attività svolte online iniziano a stare strette. Il contesto è cambiato, ed è difficile riprendersi quel legame, tornare a quella relazione, instaurata prima del lockdown. Sono stati imposti confini ben precisi, controllanti: le loro emozioni, però, non si possono reprimere.
Da circa un mese ho iniziato l’assistenza domiciliare presso le abitazioni di due bambini, uno ha cinque anni e ha una diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico. Oggi ci sono regole da seguire per poter entrare nelle case dei bambini, regole che è indispensabile rispettare ma che, allo stesso tempo, non sono state condivise e spiegate a noi operatori.
È stato detto di indossare mascherina, guanti, un lungo camice e copriscarpe. È stato richiesto alle famiglie di sanificare una stanza, di mantenere le distanze e di evitare contatti. Rispetto all’ultimo punto, inizialmente, non ci sono stati problemi: un bambino piccolo, autistico, che vede la propria educatrice varcare la soglia della propria porta mascherata come un’astronauta, difficilmente si avvicinerà. Si spaventa, urla.
Il primo giorno ho fatto qualche passo indietro, tornando sul pianerottolo di casa e, da lontano, ho tolto la mascherina. Il suo sguardo è cambiato, appariva quasi incredulo.
La madre mi riporta stanchezza, si dice esausta, racconta di aver bisogno di aiuto, di non farcela più. Suo figlio in queste settimane stava seduto sul divano a fissare il vuoto, non giocava più, non emetteva più suoni, non mangiava.
Ora, dopo un mese di incontri quotidiani, quando busso alla porta il bambino corre, ride e si avvicina per darmi la mano, cerca quel contatto a cui era abituato quando frequentava la scuola dell’infanzia. La madre sembra più serena, sorride con gli occhi.
La casa è diventata un contesto confuso, di difficile gestione: quasi un anno trascorso, cercando di entrare in relazione con il bambino, tentando di interagire senza che lui urlasse, mordesse o mi allontanasse.
Ora che cerca il contatto, che porge una sua macchinina o afferra le mie mani chiedendo di essere preso in braccio, ci viene richiesto, da regolamento, di mantenere le distanze. Tutto ciò è complesso e paradossale.
Ho sempre attribuito molta importanza ai legami, alle relazioni: penso siano fondamentali, indispensabili, soprattutto nelle professioni d’aiuto. Nonostante ciò, possono destabilizzarsi ed il loro equilibrio vacillare. Di fronte a questa situazione, in molti momenti, le emozioni sono state contrastanti: frustrazione e senso di impotenza accompagnano spesso le mie giornate ma sono, tuttavia, consapevole che non si possa avere il controllo su ogni circostanza. La mia parola chiave è: connessioni. Allungare la mano, sempre.
Cosa porta con sé il coronavirus nelle case di riposo: riorganizzazione e nuovi metodi di comunicazione
Valentina Deon, CPTF, II anno
In questo momento storico difficile, caratterizzato dall’incertezza e dalla paura che sta portando con sé la diffusione del coronavirus, i servizi residenziali rivolti agli anziani affrontano una battaglia nella battaglia.
Da una parte, le strutture si vedono costrette a riorganizzare spazi ed attività, dall’altra, le famiglie sono impegnate nella gestione della lontananza dei loro cari e delle emozioni negative ad essa connesse. Quello attuale è un momento di totale riorganizzazione, che richiede ai sistemi coinvolti una notevole flessibilità e che rende evidente l’importanza della comunicazione, fortemente esposta in queste circostanze al rischio di fallimento.
A tal proposito ritengo utile ricordare una proprietà fondamentale d’essa, il fatto che non esista un suo opposto e pertanto che: “è impossibile non comunicare” (Watzlawick et al., 1967). Partendo da questa consapevolezza diventa chiaro come tutti i comportamenti, verbali e non, rappresentino un messaggio. Anche il silenzio, il ritiro, l’indossare una mascherina… veicolano informazioni alle quali cerchiamo di attribuire un significato. Pensiamo nello specifico all’anziano che vede il personale con il volto in parte coperto dalle protezioni, il messaggio trasmesso avrà sicuramente un impatto importante, potrà essere interpretato in molti modi differenti e scatenare sensazioni diverse.
Mai come in queste circostanze diventa utile ricorrere ad una comunicazione semplice, specifica e coerente, sia con gli ospiti che con i loro famigliari.
Il lavoro con le famiglie è in questo momento di estrema importanza in quanto esse sono chiamate a ristrutturarsi, a trovare nuovi equilibri, spesso difficili… che comportano il dover fare un passo indietro rispetto all’attività di cura ed a dover riporre nell’istituzione la massima fiducia possibile. Creare connessioni e collaborazione diventa l’obiettivo primario.
Come nel contesto terapeutico anche in queste circostanze, quando si avvia una riorganizzazione dei sistemi, è importante che il nuovo “assetto” venga co-costruito.
Sfruttando le caratteristiche peculiari dei sistemi viventi, nello specifico la loro tendenza omeostatica e la loro capacità di trasformazione (Selvini Palazzoli et al., 1975), si possono trovare nuove soluzioni ed organizzazioni, più funzionali ad un contesto che attualmente è cambiato.
In uno scenario così ricco di mutamenti, ci si trova poi a dover prendere decisioni cruciali, che possono suscitare tensioni e generare frustrazione e senso d’impotenza. Ne rappresenta un esempio significativo il divieto d’accesso in struttura rivolto ai familiari.
La comprensibile sofferenza determinata dal non poter vedere i propri cari ha portato la casa di riposo dove lavoro a cercare delle soluzioni che potessero attenuare l’ansia e la tristezza degli anziani da una parte e delle famiglie dall’altra, arrivando ad introdurre la videochiamata. Essa permette ai parenti di sincerarsi anche visivamente delle condizioni di salute dei propri famigliari, un aspetto non di poco conto in questo momento d’isolamento in cui i contatti fisici non sono concessi. Per tanti l’emozione è forte, anche per gli ospiti, un po’ perché alcuni non vedono i propri cari da tanto tempo, un po’ perché questo è un metodo di comunicazione mai sperimentato prima. Sicuramente la videochiamata è stata accolta da tutti come un’opportunità positiva per avvicinarsi il più possibile nella distanza ed ha favorito lo sviluppo di una maggior fiducia dei famigliari nei confronti dell’istituzione e delle persone che la rappresentano.
I professionisti in questione, costantemente impegnati nel mantenimento degli equilibri, in quanto mai come ora mediatori tra “il dentro ed il fuori”, si sono approcciati con fiducia a questa nuova modalità comunicativa. La sua importanza è risultata subito evidente, si è immediatamente riconosciuto quanto potesse essere davvero funzionale a mantenere vive le relazioni tra gli anziani ed i loro famigliari.
In un’ottica centrata sulla resilienza, nel tentativo di attingere alle risorse potenzialmente disponibili all’interno di un contesto ricco di inevitabili limitazioni, l’utilizzo della videochiamata può quindi considerarsi una strategia vincente. Attraverso essa infatti, i famigliari si sono sentiti più vicini ai loro cari e si è potuto co-costruire un clima di fiducia e collaborazione.
Affermando la fiducia nel fatto che ognuno sta facendo del suo meglio, le famiglie hanno sostenuto i contributi di tutti e costruito le proprie competenze (Walsh, 2018). All’interno di questo scenario è diventato pertanto possibile condividere informazioni in modo chiaro e sereno, attribuendo significato ad esperienze ed emozioni, favorendo una graduale ripresa e lo stabilirsi di un nuovo equilibrio.
Bibliografia:
Selvini Palazzoli, M.; Boscolo, L.; Cecchin, G.; Prata, G. (1975), Paradosso e Controparadosso, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Walsh, F. (2018), La resilienza familiare, Milano, Raffaello Cortina Editore.
Watzlawich, P.; Helmick Beavin, J.; Jackson, D. D. (1967), Pragmatica della comunicazione umana, Roma, Astrolabio.
Anziani e morte al tempo del Covid-10, tra bisogni, relazioni e lutto comunitario
Mencacci Elisa, CPTF, II anno
“Ho paura di morire senza più poter sentire la mano di mio figlio”. Così la signora G., 96 anni con un timoroso sorriso, mi sussurra poche settimane dopo l’inizio del ciclone COVID-19, un ciclone che ha stravolto relazioni, modalità comunicative, abitudini, significati. Cosa ha segnato così profondamente la signora G. e tutti gli altri anziani, ospiti come lei di residenze “protette” e, sempre più, da proteggere?
La vita all’interno della struttura residenziale prosegue, così come la morte: gli anziani continuano ad ammalarsi, a spegnersi, indipendentemente dal virus. L’anziano sente e vede morire altri anziani come lui, ne sente parlare a volte in modo sproporzionato e non sempre contestualizzato. I mass media spesso forniscono una rappresentazione della morte come qualcosa di disumano, non controllato, innaturale, solitario.
“Essere in lutto” fa parte del processo naturale di rinnovo e di rigenerazione. Ma, di fronte ad un evento inatteso e incontrollabile come questo odierno, il lutto rischia di divenire complicato, soprattutto di fronte a fattori di rischio predisponenti quali l’assenza o l’inadeguatezza delle reti formali e informali, le difficoltà familiari preesistenti, l’assenza di lutto anticipatorio, la solitudine e l’isolamento. Questi fattori sembrano essere presenti con alta probabilità nelle situazioni di attuale restrizione dovuta alla quarantena, in particolar modo per gli anziani a domicilio soli o con gravi fragilità socio-familiari.
Il lutto è un processo e racchiude rituali collettivi, pratiche sociali e pubbliche che sono coinvolte intorno all’evento della morte (Crozzoli, 2003). Si pensi a quanto possa essere straordinariamente impattante l’impossibilità di attuare questi rituali e queste pratiche collettive: è come se il lutto oggi fosse incompleto, sospeso, parziale.
In letteratura si parla di lutto comunitario per descrivere la perdita di un gruppo piuttosto importante di persone in un determinato luogo o territorio, ad esempio in casi di guerra, attentati, catastrofi, epidemie. La mobilitazione collettiva è l’elemento che può ritualizzare tempi e spazi. Il rituale di gruppo diventa contenitore della perdita: far parte di un gruppo esteso di persone colpite in maniera simile costruisce un contenitore per il dolore, dove ci si può identificare reciprocamente e trovare forme di supporto tra pari. La presenza degli operatori è la garanzia di non essere soli in questo cammino, ma che si è comunque accompagnati nell’attraversare il fiume freddo della perdita (Cazzaniga, 2018).
L’impossibilità di condividere collettivamente la propria perdita è un fattore che rende più soli e vulnerabili. Far parte di un gruppo invece, come ad esempio in una struttura per anziani, permette di sentire il dolore condiviso, aiutando a contenere gli effetti e riducendo l’effetto psicologico della ignoranza pluralistica (ritenere di essere i soli a vivere una determinata esperienza, ignorando che esiste una pluralità di individui che hanno vissuto o stanno vivendo esperienze analoghe). Questo fenomeno di condivisione collettiva, come quello tra gli anziani della residenza, gli operatori, i familiari coinvolti a distanza, genera una connessione supportiva, creando un gruppo (più o meno visibile) il quale è capace di allestire un contesto di addomesticamento del dolore, facendone da contenitore.
Tale aspetto sembra essere un fattore protettivo dell’anziano in struttura rispetto a colui che vive a domicilio, troppo spesso non in grado di condividere collettivamente le proprie emozioni associate alle perdite, amplificando il rischio che aumentino solitudine e vulnerabilità. Il potere della connessione personale-connettiva è enorme, toglie dalla solitudine e connette a un sistema sovraindividuale (Cazzaniga, 2018).
Durante le prime settimane di chiusura, nella struttura residenziale in cui lavoro, è morto un anziano con gravi compromissioni sanitarie, ormai da giorni lontano dai suoi familiari. A causa della situazione di “emergenza” (si, perché morire di questi tempi è l’emergenza dentro l’emergenza) l’anziano ha potuto ricevere la visita della moglie, sposata con lui da oltre 50 anni e da giorni costretta a seguire da lontano gli avanzamenti della condizione del proprio caro. Un privilegio, ai tempi del COVID-19. La visita è durata circa 15 minuti e, come da protocollo, ha imposto protezioni su tutto il corpo, una mascherina strettissima, l’impossibilità di avvicinarsi l’uno con l’altra. L’addio è stato così, senza né baci, abbracci, senza tante parole, senza spazio e senza tempo, interrotto. Pochi minuti, un tenero e intenso saluto, poi il distacco. La notte stessa l’anziano se ne è andato, il suo corpo è stato portato via, in attesa di essere sepolto con le misure adeguate, senza un funerale, senza una veglia funebre.
All’interno di questo nuovo scenario ci siamo dovuti fermare, come organizzazione, per riflettere e trovare nuovi spazi di pensiero e di azione: ricercando nuove modalità di saluto, di condivisione, di confronto e di conforto, di circolazione e normalizzazione del dolore, per coloro che se ne vanno e per chi rimane. Con la forza che l’essere comunità può offrirci. Ecco che, di fronte alle perdite che l’anziano sta vivendo, occorre vivere questo lutto come qualcosa di “normale nella sua straordinarietà”, condividendo con altri e aprendosi a un senso più ampio di responsabilità e reciprocità collettiva, evitando derive solitarie dettate da una visione individualistica della propria esistenza.
Occorre lasciar andare quella rappresentazione straziante di morte “senza più posto”, l’immagine di anziani come salme da non toccare, di individui diventati numeri, di un lutto vietato, sospeso, congelato. Occorre ripartire da questa immagine, prenderne atto con consapevolezza e curiosità, per costruire nuove rappresentazioni, nuove ritualità e modalità relazionali per dire addio, per accompagnare, con dignità, i nostri anziani: nonni, compagni, genitori, parte di noi stessi e della nostra storia.
Bibliografia
Cazzaniga, E. (2018), Il lutto, s.l., Outis.
Crozzoli, A. (2003), I giorni rinascono dai giorni, Roma, Edizioni Paoline.
Mencacci, E.; Bordin, A.; Busato, V. (2020), Non sono più: Come fronteggiare l’interminabile lutto nella demenza, Castel San Giovanni, Editrice Dapero.
Mencacci, E.; Galiazzo, A.; Lovaglio, R. (2015), Dalla malattia al lutto: Buone prassi per l’accompagnamento alla perdita, Milano, Casa editrice Ambrosiana, Zanichelli.
Covid-19 e lavoro: cambiamenti, crisi, opportunità
Federica Maressa, CMTF, I anno
Lavoro nella divisione risorse umane di una grande multinazionale, mi occupo di selezione, formazione e sviluppo dei collaboratori.
Mi trovavo in montagna, Val D’Aosta, a passare le vacanze di carnevale con la mia famiglia, domenica 23 Febbraio, quando ho letto le prime mail sul telefono aziendale dove ci informavano che dal lunedì 24 Febbraio, avremmo attivato la modalità smart working per tutti i dipendenti delle sedi di Veneto e Lombardia.
Avevo seguito le informazioni relative al virus già da dicembre, sapevo cosa volesse dire, ma ancora era un’entità lontana, immaginata, compresa, ma non realistica. Da qualche giorno le notizie si erano fatte più concrete, Codogno, Bergamo, le zone rosse, la chiusura delle scuole: in quarantotto ore l’entità Covid-19 era diventata reale, concreta, nociva.
E così scuole chiuse e tre figli a casa, smart working per me e mio marito, incertezza, caos, vita da riorganizzare.
La mia attività lavorativa è andata avanti, per dirla in termini aziendali “il business non si è fermato”, riunioni via webex, piattaforme e-learning, colloqui di selezione, persino un assessment di selezione virtuale e degli incontri di supporto ai colleghi.
Ma se dovessi descrivere questo periodo di lockdown utilizzando solo tre parole, immagino scorrere su un backdrop con fondo bianco, i seguenti termini scritti in grassetto con inchiostro nero:
Confini, tempo, relazioni.
Confini. La casa è diventata il porto sicuro, il luogo protettivo, il rifugio da Covid-19; al suo interno, una stanza, si è trasformata in ufficio: il computer, il telefono, una sedia comoda e soprattutto una buona connessione internet, perché l’unica possibilità di contatto professionale con l’esterno era attraverso le piattaforme virtuali. Ma mentre la casa è stata un fortino che ci ha protetto dalla minaccia esterna, trovare uno spazio proprio, all’interno delle stesse mura, è stato difficile; in alcuni momenti è diventata un’abitazione stretta per ospitare cinque conviventi, se pur spaziosa. La fatica è stata trovare un luogo isolato, silenzioso e privo di incursioni improvvise, la percezione era quella di non avere confini, di aver perso un luogo – il luogo di lavoro – che rappresenta una dimensione individuale, personale e non necessariamente condivisa con i familiari.
Tempo. Durante questa pandemia ho sperimentato un nuovo approccio sulla gestione del tempo, la pianificazione delle attività giornaliere era diventata più fluida, lontana dai ritmi serrati: sveglia, scuola dei bambini, corri in ufficio, lavora, riprendi i bambini, portali allo sport, torna a casa etc… la sensazione generale è stata di lentezza, improvvisamente nessuno aveva più fretta di avere risposte immediate alle mail, di avere le riunioni in agenda, di far squillare il cellulare, per qualche settimana abbiamo lavorato sospesi, senza pianificazione.
In un primo momento è stato destabilizzante, una perturbazione: “smettere di essere sempre di corsa, non più criceti dentro ad una ruota!”, ma poi, piacevolmente si è concretizzata la realtà di avere più tempo, di essere artefice degli orari e degli impegni, effettivamente avevo guadagnato ore libere, avendo anche eliminato dalla routine i tempi trascorsi in macchina per gli spostamenti. L’opportunità è stata quella di lavorare, non in maniera reattiva (domanda – risposta), ma in modo progettuale, poter essere più creativi, condividere idee con i colleghi, confrontarsi senza fretta. E così durante alcune riunioni virtuali, con il team dei colleghi abbiamo iniziato a confrontarci su possibili scenari futuri e su alcuni cambiamenti che avremmo potuto sperimentare, modalità nuove di fare recruiting, tour virtuali dell’azienda per i nuovi collaboratori, programma di induction per i neoassunti con l’assegnazione di un “tutor” virtuale, iniziative di supporto psicologico per i dipendenti e le loro famiglie, attività di promozione del benessere psicofisico con sessioni on line di yoga o fitness.
L’unico aspetto difficoltoso della gestione del tempo e strettamente legato alla percezione dello spazio, è stato l’interferenza, nell’arco della giornata, tra i diversi “ruoli della vita”, tempo fluido, senza orari netti.
Nello stesso ambiente e nelle stesse ventiquattro ore, in maniera repentina e del tutto flessibile si passava a essere da professionista a madre, da cuoca a maestra, da studentessa a moglie.
Vivere contemporaneamente queste realtà non è stato semplice, soprattutto perché gli switch veloci non sempre permettevano di restare concentrati e focalizzati sugli obiettivi.
Relazioni. L’aspetto più limitante è stato dover portare avanti tutti i contatti e le relazioni lavorative solo attraverso telefono, call, videochiamate. Al di là delle problematiche tecniche di piattaforme poco stabili o connessioni internet deboli, la reale fatica è stata quella di imparare a comunicare attraverso il filtro dato dallo schermo del monitor, anche questo una barriera, un confine. Durante i colloqui di selezione con i candidati, via Skype ho perso i loro sguardi, il loro tono di voce, la loro postura, tutti quegli aspetti “non verbali” che parlano molto! Allora i colloqui sono diventati conversazioni in cui ho cercato di farmi raccontare di più della loro vita, delle loro esperienze, anche condividendo i loro vissuti durante questa pandemia.
Al contrario gli appuntamenti con i colleghi sono stati momenti di confronto e conforto, al di là dei contenuti lavorativi, lo scambio di esperienze, il raccontarsi gli stati d’animo e le difficoltà del lockdown hanno creato un senso di vicinanza e appartenenza annientando le distanze reali.
La chiacchierata alla macchinetta del caffè è stata sostituita dalla videochiamata di gruppo Whatsapp e la domanda spesso utilizzata da intercalare “come stai?” in cui distrattamente si ascoltava la risposta, si è caricata di significato e di empatia.
La percezione dopo 94 giorni di quarantena è quella di essersi abituati a questo nuovo modo di lavorare e di relazionarsi con gli atri, con tutte le difficoltà che questo ha comportato, ma il turbamento provato adesso deriva dall’incertezza di un ulteriore cambiamento: “come sarà” quando torneremo in ufficio?





